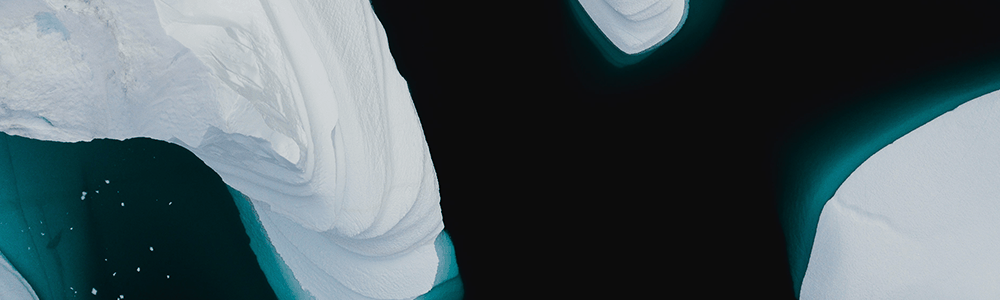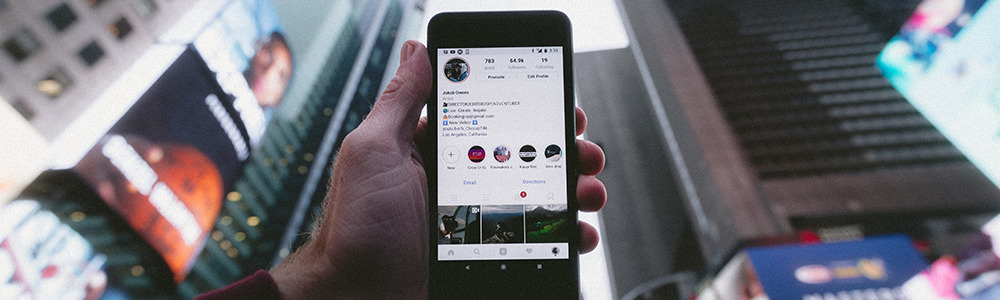Sul nostro magazine oggi vogliamo riportarvi l’intervista a Tiziana Monterisi, CEO e Co-fouder di Ricehouse, startup innovativa e società benefit impegnata nel settore della bioedilizia con l’obiettivo di sviluppare prodotti e servizi attraverso la valorizzare degli scarti del processo di coltivazione del riso.
Tiziana, com’è nata l’idea e da quanto tempo siete attivi sul mercato?
“Ricehouse è stata costituita a fine 2016 ed è entrata sul mercato, quasi con esattezza, un anno dopo, con la prima fiera che abbiamo fatto, CasaClima 2018, dove ci siamo presentati al mercato con i primi 3 prodotti. In realtà l’idea è nata molto prima. Fin dall’università mi sono sempre occupata di architettura sostenibile e di cercare soluzioni alternativa sia a livello di materiale sia a livello di tecnologie.
Successivamente, tra il 2010 e il 2012, ho iniziato a pormi delle domande rispetto a quello che vedevo bruciare all’interno dei campi di riso, e da lì è nata tutta la mia ricerca legata agli scarti del riso, l’uso della paglia (anche in architettura) e il mancato impiego della paglia di riso rispetto, invece, ad altre tipologie di paglie.
Prima della nascita della nostra startup è stata svolta un’analisi all’interno del mio studio di architettura legata alla ricerca dei materiali naturali e alla sperimentazione, anche nei miei cantieri. In questo discorso si inserisce anche la casa in cui viviamo, costruita nel 2013 e che rappresenta il nostro esperimento costante. Da queste fasi abbiamo compreso di avere un materiale molto interessante dal punto di vista tecnico-scientifico, per le sue prestazioni, e soprattutto dal punto di vista dell’impatto ambientale. A tutto questo si unisce la consapevolezza da parte nostra di avere realmente in mano una situazione che davvero potrebbe cambiare il settore dell’edilizia, il terzo più impattante che l’uomo realizza tutti i giorni. La mia volontà consisteva nel portare quello che avevamo fatto in maniera artigianale e in quantità molto piccola, a livelli industriali.
Da qui decidiamo di fondare Ricehouse, io e il mio compagno (50-50%), dove, per 4 anni, assieme ai miei colleghi dello studio di architettura, abbiamo da un lato, in maniera parallela, mantenuto e continuato la progettazione, dall’altro abbiamo cominciato a cercare partner industriali per rendere industriale il prodotto che avevamo fatto a livello artigianale. Abbiamo pertanto brevettato delle ricette e trovato dei partner industriali. Oggi lavoriamo con 5 produzioni diverse, non ci limitiamo ad un solo prodotto. Quello che abbiamo fatto, e che continuiamo a fare costantemente, è la ricerca su come è possibile sostituire alcuni materiali dell’edificio attraverso lo scarto del riso. Nello specifico, lo scarto del riso rappresenta la componente principale mentre il legante è quella piccola parte che però, per noi, è molto importante perché sia sempre naturale, formaldeide free, che a fine vita mi possa permettere di: compostare il materiale, riciclarlo al 100% per rifare lo stesso materiale oppure riciclarlo per ottenere altre cose come i sottofondi stradali o altro.
Ad oggi il team è composto da 16 persone, lo studio è stato completamente integrato all’interno della startup e ci occupiamo di 3 grandi tematiche basate sui concetti di economia circolare e di valorizzazione dello scarto di riso.
Abbiamo l’unità progetto, all’interno della quale sviluppiamo progetti che facciamo realmente in maniera totale, a partire dalla pratica fino ad arrivare alla realizzazione.
La seconda area è l’unità prodotto, incentrata sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti che, attraverso i partner industriali, produciamo per venderli in maniera diretta. Ad oggi non abbiamo una rete commerciale, non abbiamo negozi e rivendite, vendiamo in maniera diretta tutto: mattone, pittura, intonaco, sottofondo, pannello. Tutto ciò che serve per comporre un edificio a impatto zero, esclusivamente fatto con materiale derivante dallo scarto del riso, ad esclusione del materiale per la struttura. Questa può essere di 3 tipologie: cemento armato classica, acciaio oppure in legno. Noi prediligiamo quella in legno assemblata a secco con tutta l’innovazione tecnologica ma di fatto i nostri materiali possono essere usati da chiunque, sia per nuove costruzione sia per ristrutturazioni.
La terza unità è l’open innovation che si occupa di ricerca e sviluppo, sia per nuovi prodotti che vogliamo portare sul mercato, sia con altre (anche grandi) aziende interessate a collaborare per cercare di capire come il nostro scarto possa valorizzare la loro produzione e renderla sostenibile.
Oggi Ricehouse è sì una startup innovativa ma, di fatto, ha 3 grandi unità che vanno dal chi vuole il “chiavi in mano” in casa di riso progettata da noi, a chi vuole solo il prodotto, a chi invece collabora con noi per svolgere continuamente ricerca e sviluppo.”
Come funziona il vostro modello di economia circolare e quali servizi e prodotti offrite?
“Abbiamo analizzato la filiera del riso e ciò che ci ha spinto a capire che era molto stimolante, riuscendo a vedere una risorsa all’interno della risaia, risiede nel fatto che, innanzitutto, l’Italia rappresenta il primo produttore in Europa di riso (e noi siamo finiti con il vivere a Biella, il paese più a nord che produce riso), ma questo è presente in tutti e 5 i continenti, in più di 100 paesi, e la stessa materia prima è presente annualmente, anzi, in Asia, ad esempio, fanno 2 raccolti all’anno, a volte anche 3. Lo scarto rappresenta circa il 30% della produzione. Noi valorizziamo solo ed esclusivamente questo scarto che si compone principalmente di paglia e di lolla (la pelle del chicco), gli elementi più importanti che oggi vengono letteralmente bruciati, emettendo CO2. Da qui, produciamo materiali naturali al 100%, attraverso l’impiego di leganti diversi, come amidi, magnesite, argilla. A fine vita avranno destinazioni diverse.
Per me, ripeto, l’impatto ambientale è sempre stato molto importante, pertanto il discorso alla base è: oggi lo produco, generando un impatto, poi verrà usato dall’operaio per 40 anni, generando su se stesso un impatto molto forte, e, a fine vita, l’impatto dovrà essere zero.
Ecco perché la nostra ricerca è sempre stata nel legante, che a volte è quel 5-10% ma che è molto importante, perché, se fosse un legante chimico, il prodotto non sarebbe più riciclabile o compostabile. I nostri materiali invece, a seconda del legante, hanno 3 destinazioni.
Possono essere riciclati, per ottenere lo stesso prodotto, o vengono triturati, per fare sottofondi stradali (abbiamo un legante che rende inerte lo scarto), oppure vengono messi in un biodigestore, quelli compostabili, producendo energia elettrica e termica e ottenendo un fertilizzante che può tornare direttamente al campo di riso. Ecco perché la filiera è veramente chiusa, senza la produzione di nessun tipo di rifiuto.
Oltretutto, aspetto molto importante, attiviamo una nuova filiera. Ricehouse è al centro di questa filiera (una sorta di snodo) che parte dall’agricoltore, il primo soggetto che opera sul campo, da quale compriamo la paglia, che così non viene bruciata. Nello specifico, non paghiamo tanto per lo scarto, quanto la lavorazione che l’agricoltore fa per noi, quindi la raccolta, lo stoccaggio, l’imballaggio. Deve seguire un protocollo che per noi è fondamentale per rendere quel sottoprodotto agricolo un prodotto industriale per le costruzioni. In questo modo loro hanno una nuova microeconomia e un risparmio. Il risparmio è dato dal fatto di non dover più bruciare, dal non dover pagare multe (molto salate) a livello regionale perché non devono più entrare nel campo a trinciare, quindi risparmiano gasolio e manodopera. In più hanno una nuova economia, perché fisicamente noi li paghiamo.
Da un altro lato, lavoriamo con diversi partner industriali italiani che producono riso. In questo caso, facciamo arrivare lo scarto, lo lavoriamo se deve essere lavorato, perché, ad esempio, la paglia e la lolla in alcuni prodotti vengono usati tali e quali, in altri abbiamo invece la necessità, per esempio, di macinarli, di sfibrarli, di ridurli. Quindi noi facciamo fare al terzista questa lavorazione e poi arriva al processo industriale. Per esempio abbiamo messo a punto una miscela di lolla che serve per la stampa 3D dove stampiamo oggetti di design. Ovviamente lì la pelle del chicco non può essere tale e quale perché è grande circa 5 mm, ma viene micronizzata, quindi noi facciamo fare al terzista prima questa lavorazione e poi viene mandata alla stampa in 3D dove facciamo l’altra miscela. Quindi noi gestiamo tutta la filiera. Quando il prodotto è pronto, viene commercializzato e arriva all’impresa edile che realmente lo utilizza nel suo cantiere.”
Quali risultati avete ottenuto in termini di edifici costruiti, collaborazioni e riconoscimenti?
“In termini di edifici costruiti, ad oggi abbiamo più di venti case interamente progettate e costruite da noi e più di 90 cantieri che hanno utilizzato i nostri prodotti, a volte alcuni, a volte tutti, dipende dalle situazioni. Grazie all’incentivo del Governo del superbonus per il decreto crescita avremo un esplosione, perché solo quest’anno stiamo progettando 20 nuovi cantieri di cui 4 grandi condomini (uno a Milano, molto grosso, che porteremo a energia zero attraverso un cappotto fatto di lolla).
Prima di parlare dei riconoscimenti ottenuti, vorrei dire che inizialmente abbiamo provato su di noi, in maniera artigianale fatto in cantiere, all’interno del quale ero il direttore dei lavori e pertanto poteva prendermi le responsabilità. L’abbiamo provato con diversi clienti. Una delle prime case è stata costruita nel 2016 a Chamois, in alta Valle d’Aosta, ed è stata premiata anche come casa sostenibile nel 2017. Il cliente, in quel caso, era ben consapevole del fatto che erano tutti materiali sperimentali ma era molto illuminato e intenzionato nel volere una casa di riso, senza riscaldamento, e si è affidato alla nostra progettazione. Da quel momento abbiamo capito che potevamo davvero fare la differenza nel mondo dell’edilizia industrializzando qualcosa che in realtà è sempre stato usato in antichità, perché non ho inventato niente, lo trovavo nelle cascine e nelle ristrutturazioni di case storiche. Utilizzavano questi materiali perché erano quelli che avevano a disposizione.
Il poter fare il passaggio e renderlo industrializzabile, dialogabile realmente con i macchinari, con la manodopera, con le logiche del cantiere di oggi, è sicuramente stato, ed tutt’oggi, un grande impegno nel quale noi crediamo e investiamo, perché potremmo davvero ridurre l’impatto dell’edilizia in maniera drastica perché, di fatto, la materia prima è presente in quantità infinita e si rinnova ogni anno, quindi non abbiamo problemi di materia prima. Dall’altro, se riuscissimo ad aumentare le produzioni, potremmo veramente fare la differenza sul mercato.
I riconoscimenti sono stati davvero tanti dal 2018, quando ci siamo presentati a CasaClima, la fiera più importante in Italia sull’edilizia sostenibile. Abbiamo ottenuto un doppio riconoscimento in termini di innovazione di prodotto, perché sostenibile ed efficace, e di impresa. Abbiamo ottenuto diversi premi come progetto imprenditoriale legato al concetto di economia circolare e di impatto, sia livello ambientale che sociale, pur essendo una società profit che vuole fare business. A livello societario, dall’anno scorso ci siamo trasformati in una società benefit e abbiamo fatto la certificazione B Corp perché, voglio sottolineare, la nostra intenzione è sì quella di fare profitto ma ponendo massima attenzione all’ambiente e all’ambito sociale. Quando ne parlavamo quasi dieci anni fa eravamo visti come dei matti, oggi in realtà sono tante le aziende, anche quelle molto grandi, che parlano e tornano a definire un’etica del business. Oggi lo si può fare anche a livello societario, dove essere una società di capitale (S.r.l. o S.p.A.) può essere anche una S.B., società benefit, dove, a fine anno, è presente non solo un bilancio economico ma anche a livello di impatto ambientale e sociale. Per noi rappresentano i pilastri della nostra startup.
A livello di numeri, siamo passati da 4 persone a 16. Abbiamo avuto una grande evoluzione, soprattutto negli ultimi 7 mesi, perché fino a settembre eravamo in 6, da settembre ad oggi sono entrate 10 persone nuove. Non è semplice perché da un lato c’è tanto lavoro e dall’altro c’è l’inserimento di tante nuove persone.
Tutto era nato proprio dal fatto di aver costruito questa casa, anche molto grande, ma noi effettivamente siamo soltanto in 3 (io, il mio compagno e nostra figlia). Da qui, la decisione di mettere l’ufficio al suo interno, perché ci rappresenta. Il problema è che oggi siamo in 16 e quindi c’è questa grande commistione, quasi un po’ comunitaria, soprattutto perché da un anno non usciamo più. Però di fatto ci ha davvero molto rappresentato. Le persone che vengono qui, nel momento in cui vedono con i loro occhi il fatto che la casa non ha riscaldamento, non ha condizionatore, è isolata e rifinita con i nostri materiali, è sempre stata una carta vincente, e ci rappresenta realmente. Adesso però non ci stiamo più perché siamo oggettivamente troppi quindi stiamo immaginando una nuova sede.
Anche a livello numerico abbiamo sempre raddoppiato il fatturato: l’anno scorso abbiamo chiuso a 345 mila euro e quest’anno pensiamo di decuplicare il fatturato, quindi arrivare a quasi 3 milioni di euro.”
Durante il vostro percorso quali difficoltà avete riscontrato e che impatto ha avuto il Covid-19 sulla vostra attività?
“15 anni fa, quando ho iniziato a utilizzare questi materiali e parlarne, non c’era veramente consapevolezza. I pochi clienti erano veramente molto illuminati dal punto di vista alimentare, quindi più legati al concetto di salute e ad una alimentazione biologica e sana. Quindi una serie di aspetti, provenienti da altri ambiti, che li portava ad avere un edificio “sano”. Oggi, soprattutto con il Covid, si è verificato un grande cambio epocale, a livello proprio di consapevolezza in quanto, a causa del fatto di dover rimanere nelle proprie abitazioni, si è capito che forse le nostre case non sono così sane. Soprattutto per chi vive in ambienti piccoli, senza un giardino, un terrazzo e non potendo uscire.
Anche dal punto di vista imprenditoriale si è verificato un cambiamento. 15 anni fa, quando disegnavo le mie filiere a ciclo chiuso (non si chiamava economia circolare) e i metanodotti che portano il petrolio dall’Arabia a qui, la gente mi guardava veramente molto stranita, perché secondo loro il business era altro e quella lì sarebbe rimasta una nicchia. Oggi invece non è una nicchia.
Oggi però bisogna parlare di economia circolare “seria”, perché, purtroppo, ancora viene associata al concetto di riciclo ma il riciclo non è economia circolare. Questo non vuol dire che bisogna partire sempre e solo dalla natura. Io non sono contro la plastica e la chimica, sono per provare delle soluzioni che veramente possano chiudere quel cerchio e quindi, se parto da un polimero, devo poter tornare a quel polimero. Il problema della nostra generazione risiede nel fatto che siamo cresciuti 4 volte rispetto alla popolazione mondiale ma il nostro consumo di materia è cresciuto 12 volte, quindi utilizziamo in maniera esponenziale tutto ciò che è prodotto (dentifricio, spazzolino, macchina, scarpe, qualsiasi cosa noi utilizziamo ogni giorno).
Oggi abbiamo tutti molto chiaro la questione ambientale. L’Europa ce l’ha chiaro, la Cop21 a Parigi ha dettato dei parametri molto precisi per arrivare al carbon zero e, per arrivarci, dobbiamo fare una scelta davvero molto drastica oggi, dal punto di vista di “smetto l’economia lineare per l’economia circolare”, ognuno nel suo ambito, perché la materia è molto facile da capire ed è chiaro che ci sono i sacchetti di plastica in mare ma, per esempio, l’uso del digitale, non ce ne rendiamo conto, ha un impatto a livello di CO2 elevatissimo. Mandare un’email emana non so quanti kg di CO2 e i server Google per essere raffrescati hanno bisogno di tutta una tecnologia che emana CO2, quindi anche quello che è la materia che non possiamo percepire, che non è tangibile, ha un impatto ambientale molto elevato. Ripensare il nostro stile di vita in maniera veramente sostenibile è ormai un’esigenza costante, non possiamo più farne a meno. Ognuno nel suo ambito, perché ovviamente non è che tutto può essere giusto se è naturale. Se taglio un albero e non lo rimpianto, può essere considerato naturale ma sto facendo una cosa sbagliata. Quindi è veramente il riuscire a guardarsi da fuori e ripensare i nostri modelli di business, perché noi viviamo su delle economie, e domandarsi allora se può essere davvero sostenibile un’economia, dal punto di vista economico, sennò non è business, dal punto di vista sociale e ambientale. Se riusciamo davvero a fare questo, i giovani avranno un futuro davanti, altrimenti la vedo davvero molto drastica. Anche se io sono molto positiva e cerco delle soluzioni, queste però vanno volute da tutti, non più da una nicchia.”
Avete recentemente ottenuto un finanziamento di 600 mila euro, come saranno investite le risorse ottenute e quali sono i vostri obiettivi per il futuro, sia dal punto di vista nazionale che internazionale?
“L’anno scorso abbiamo vinto B-Heroes, un programma di accelerazione per startup. Quella vincita ha fatto sì che decidessimo appunto di aprire la società a un round di investimento, perché la società è stata fondata da me e il mio compagno, ma abbiamo ritenuto che eravamo abbastanza forti per aprire una società e diventare grandi in qualche modo. Sono entrati degli importanti soci come Riso Gallo, Jean-Sébastien Decaux, il Fondo Avanzi, un fondo di Giordano Dell’Amore, e Banca Etica che investe sull’impatto ambientale e l’impatto sociale. Riteniamo che con quella parte di investimento riusciamo a solidificare, in maniera scientifica, la veridicità dei nostri prodotti. Stiamo pertanto attivando tutta una serie di certificazioni, a livello proprio di prodotto, oltre all’investimento in nuovi prodotti, ad oggi non impianti, perché crediamo di poter continuare a lavorare con partner industriali, e abbiamo la visione di poter veramente interfacciarci con il mercato non solo italiano, dove ovviamente questo 110 ci da un aiuto in termini di sviluppo, ma soprattutto con i mercati europei, per quanto riguarda il nostro prodotto venduto lì, e i mercati asiatici, per quanto riguarda l’esportazione di tutto il know-how e di tutta la filiera.”
Ultima domanda: quali consigli daresti a chi, come voi, è mosso dalla volontà di innovare?
“Sicuramente il credere in se stessi, provare davvero a sviscerare l’idea e con caparbietà, se si crede in quell’idea, di non mollarla. Se penso a me un anno fa, quando tutti mi dicevano “ma tanto sei un architetta che fa case di paglia”, in realtà no, io credevo e credo nella sostenibilità. L’aver tenuto l’asticella sempre molto alta e la mia visione molto chiara, mi hanno permesso di arrivare oggi a fare la differenza sul mercato, quindi sicuramente credere in se stessi, credere nell’idea e non aver paura di fallire, perché il fallimento fa parte della crescita e quello che oggi può sembrare un fallimento invece magari è un insegnamento pazzesco che ti permette di fare un salto di qualità. Io prima di aprire Ricehouse ho avuto per 10 anni un’impresa edile che commercializzava materiali naturali prodotti all’estero, ovviamente non avevamo clienti, non commercializzavamo proprio a nessuno perché non era proprio il momento. Quindi, con dispiacere, abbiamo chiuso questa società ma, di fatto, è stata una grandissima esperienza che mi ha permesso di scegliere qual era il materiale e aprire Ricehouse. Forse se non avessi fatto quell’esperienza, oggi non sarei stata qui. Quindi bisogna vedere il fallimento non come un aspetto negativo, cosa che per gli italiani non è così, ma sempre come un grande momento di crescita.”