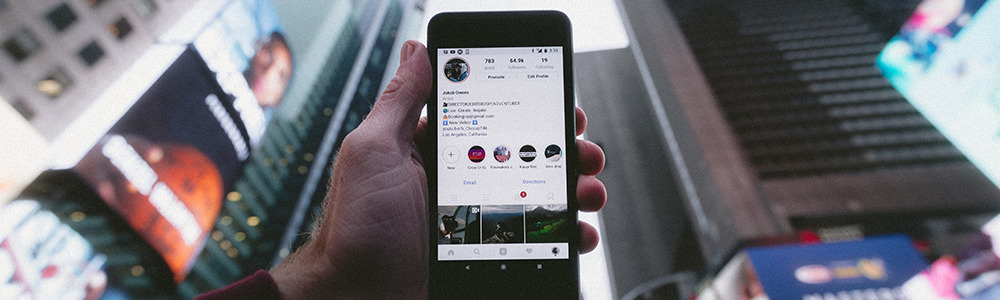La shrinkflation e quel caro mezzo chilo di pasta
La guerra in Ucraina, l’aumento esorbitante dei costi di gas e luce e gli effetti della pandemia sono eventi che hanno indubbiamente impattato in modo determinante sulla vita di ognuno di noi.
Al giorno d’oggi, siamo costantemente bombardati da centinaia di informazioni diverse che ci investono in ogni ambito della nostra quotidianità. Dai social, alla tv, alle sale d’attesa, fino al bagno di casa, ogni nostra azione è sempre accompagnata da una voce narrante che, in sottofondo, ci ricorda che non siamo altro che un minuscolo granello in un Universo in continua trasformazione. Questa overdose informativa ha però un duplice effetto: se da un lato la conoscenza degli eventi ci rende più consapevoli di ciò che accade intorno a noi, dall’altro l’eccesso di news ha l’effetto collaterale di stordirci, nel mare di cambiamenti che sta investendo la popolazione mondiale.
In tutto questo caos infatti, rimaniamo spesso attoniti ed impotenti di fronte al drammatico evolversi degli eventi, assorbendo passivamente il cambiamento.
Se però l’aumento delle tasse, per esempio, rappresenta una manifestazione chiara (ed indigesta) che le cose stiano mutando, la shrinkflation è un processo sottile, al limite dell’impercettibile, che testimonia il continuo rimodellamento delle dinamiche economico-sociali che regolano la nostra vita su questo pianeta (e di cui spesso non ci rendiamo conto).
Per comprender di cosa si tratti questo complesso fenomeno, le cui implicazioni vanno ben oltre il semplice aumento del costo degli ingredienti di una degna carbonara, è opportuno innanzi tutto chiarire qualche concetto.
Cos’è la shrink-flation?
L’espressione è un neologismo che nasce dall’unione di due termini: “shrinkage”, ovvero contrazione, ed “inflation”, cioè inflazione (un rincaro di larga portata). La shrinkflation si configura come una tecnica di marketing molto fine che ha l’obiettivo di aumentare il margine di profitto sul prodotto attraverso un processo di riduzione delle dimensioni del bene di consumo.
Essa si basa essenzialmente sulla “sgrammatura” seriale dei prodotti, cioè la riduzione del contenuto delle confezioni. Questo espediente permette che il prodotto acquisisca una dimensione minore rispetto a quella canonicamente conosciuta dal compratore, mantenendo però lo stesso prezzo.
Questo processo di riadattamento di prezzi e volumi ha impattato in maniera determinante sui beni di largo consumo, sfruttando la familiarità del compratore al prodotto per indurlo a pagare un prezzo più alto senza che, nella maggior parte dei casi, se ne possa accorgere.
Un esempio eclatante di shrinkflation è quello del nuovo pacco di pasta da 400g che ha sostituito il classico e consolidato mezzo chilo ma che viene comunque venduto allo stesso prezzo. Il cliente (che potrei essere io, una studentessa fuori sede che al supermercato ha ben altro a cui pensare che non controllare la grammatura della pastasciutta), in linea generale, possiede una certa familiarità con il prodotto e, proprio in virtù di questa consolidata fedeltà, è tratto in inganno: convinto di acquistare un pacco da 500g, in realtà, si ritroverà nella mensola una confezione di soli 400g, finendo per pagare un prezzo maggiore senza rendersene effettivamente conto.
La strategia di ridurre la dimensione del prodotto pur mantenendo lo stesso prezzo a cui il consumatore è “affezionato”, permette infatti di abbattere notevolmente il rischio di perdita della clientela (rispetto a quanto potrebbe accadere alzando direttamente il prezzo sulla confezione), garantendo di massimizzare il guadagno a scapito del compratore.
Questo meccanismo, che pecca sicuramente di trasparenza, ha suscitato non poche polemiche e rivendicazioni. Attualmente infatti molte Associazioni dei consumatori ed alcune Procure della Repubblica hanno presentato denuncia all’Antitrust per verificare la legalità della pratica e tentare di regolamentarla.
Storia di un consumatore ingenuo
Pensare che gli eventi che accadono lontano da noi non possano ripercuotersi sulla nostra esistenza è frutto di una visione non solo miope ma anche estremamente fallace.
Al contrario degli effetti palesi ed evidenti dei profondi cambiamenti che hanno investito recentemente l’Occidente (e non solo), la shrinkflation è un processo che agisce tra le righe, esercitando una pressione economica (e psicologica) su ognuno di noi senza che, nella maggior parte dei casi, possiamo accorgercene in maniera totalmente consapevole.
Ogni cambiamento comincia con la presa di consapevolezza: solo comprendo che la realtà attorno a noi sta cambiando, infatti, possiamo opportunamente riadattare il nostro comportamento al continuo evolversi delle dinamiche che regolano la nostra quotidianità.
Tale presa di coscienza viene meno nel caso della shrinkflation: essa infatti si basa su un processo di reticenza più sottile e tagliente di quanto non possa sembrare, rendendoci vittime di un meccanismo subdolo e basato sulla nostra stessa ingenuità.
É possibile inoltre notare come questo fenomeno attinga parte dalle sua consistenza dal principio della rana bollita di Chomsky, secondo cui l’essere umano perde la capacità di reagire a situazioni spiacevoli, adattandosi gradualmente e passivamente ai sottili cambiamenti della realtà che lo circonda.
Esattamente come la rana, che viene bollita in una pentola d’acqua senza che possa rendersene conto aumentando gradualmente la temperatura, anche noi diventiamo inerti e passivi di fronte alle evoluzioni della nostra società, accettando le trasformazioni senza cognizione di causa.
In questo modo, la shrinkflation avviene costantemente e ripetutamente sotto il nostro naso, ma non siamo capaci di accorgercene.
Nella botte piccola c’è il vino buono (o forse no?)
Tra i potenziali vantaggi di questa metodica c’è anche l’ipotesi, secondo alcuni, che permetta di tamponare il dislivello presente tra l’eccesso della domanda rispetto alla contrazione dell’offerta.
L’Ucraina, per esempio, è una delle maggiori esportatrici di grano, mais e molti tipi di cereali. A seguito dell’atroce guerra a cui è stata condannata dall’invasione russa, però, la produzione di grano ha subito una contrazione sensibile rispetto alla domanda. Ciò ha comportato, tra i vari effetti, anche un aumento drastico dei prezzi del grano e dei panificati da esso derivati (come pane e pasta). Secondo alcune analisi, sembrerebbe che l’aumento del prezzo dei prodotti e la corrispondente riduzione del contenuto attraverso la sgrammatura possano cooperare per ristabilire un equilibrio tra domanda ed offerta, contribuendo anche a ridurre lo spreco alimentare.
Nonostante il principio possa essere giusto ed auspicabile però, in questo caso, è la modalità adottata ad essere in difetto.
La vendita e la compera dei prodotti, specialmente quando si tratta di beni primari, dovrebbe essere quanto più onesta e trasparente possibile, al contrario di quanto accade attraverso la pratica della shrinkflation, che si basa su un abile gioco al confine tra truffa e marketing ai danni del rispetto per il cliente.
Potrà essere anche è vero che nella botte piccola c’è il vino buono, ma a che prezzo?
Come sfuggire alla shrinkflation? (Spoiler: non è possibile)
Purtroppo, sembra che attualmente questo fenomeno stia dilagando a macchia d’olio, investendo diversi campi del settore produttivo.
Tra gli esempi più tangibili dell’applicazione di questa tecnica, oltre alla sgrammatura (cioè alla diminuzione) dei grammi delle confezioni di pasta, c’è la riduzione del numero di crackers nei pacchetti, che passano da 5 a 4 per sacchetto, accompagnata dalla diminuzione del peso delle mozzarelle (che passa da 125 a 100g per pezzo), fino alla riduzione del volume di molti prodotti liquidi, come dentifrici (da 100 a 75ml), gel o creme, spesso accompagnata da un remodelling del packaging, che consente di mantenere la stessa grandezza della confezione pur diminuendo lo spazio interno effettivamente dedicato al prodotto, impedendo al compratore di percepire la variazione.
Massimiliano Dona, avvocato ed attivista che si occupa principalmente di tematiche legate al consumo, ha recentemente presentato un’Audizione in senato in merito al DDL sulla concorrenza in cui ha parlato di shrinkflation. Dona, oltre a spiegare in maniera estremamente chiara molte dinamiche inerenti al mondo del consumo e alle tecniche di marketing ad esso associate, fornisce anche consigli pratici ed utili per renderci consumatori più informati e consapevoli.
Secondo Dona, una delle tecniche che possiamo attuare per tentare di sfuggire a questa spirale è quella di controllare il prezzo in euro al kg o al litro. Questa pratica però risulta il più delle volte molto laboriosa e spesso si è costretti a rinunciarvi.
L’educazione del consumatore quindi non è generalmente sufficiente a garantire un consumo equilibrato e consapevole. É perciò opportuno che i produttori si prendano le responsabilità comunicative delle loro vendite.
Alla luce di ciò, sarebbe quindi auspicabile prevedere degli obblighi informativi che garantiscano di rendere palese ed evidente la sgrammatura del prodotto rispetto alla dimensione standard, in modo tale che il compratore possa apprenderne la variazione e valutare così i suoi bisogni effettivi.
Sicuramente, in un mondo ormai saturo di stimoli e pressioni, onestà e trasparenza sono elementi imprescindibili, soprattutto quando si parla di beni di prima necessità.
Pur garantendo ovviamente la piena libertà del produttore nel variare e decidere le dimensioni dei beni venduti, è fondamentale preservare il rispetto verso il consumatore e la sua autonomia di giudizio in merito ad acquisti che devono necessariamente essere compiuti nel massimo della trasparenza.