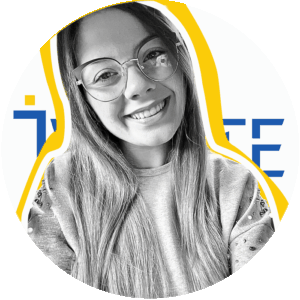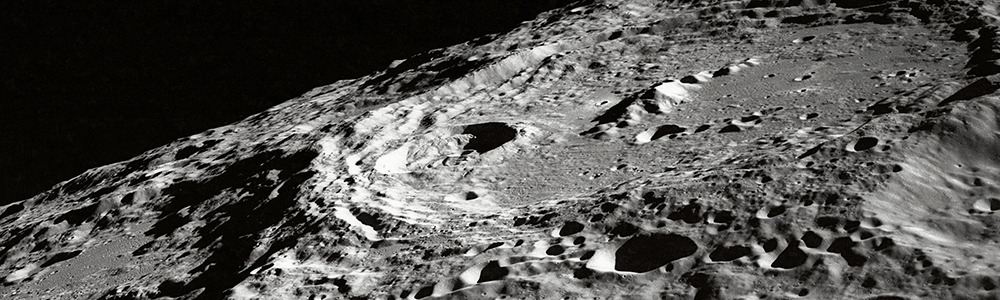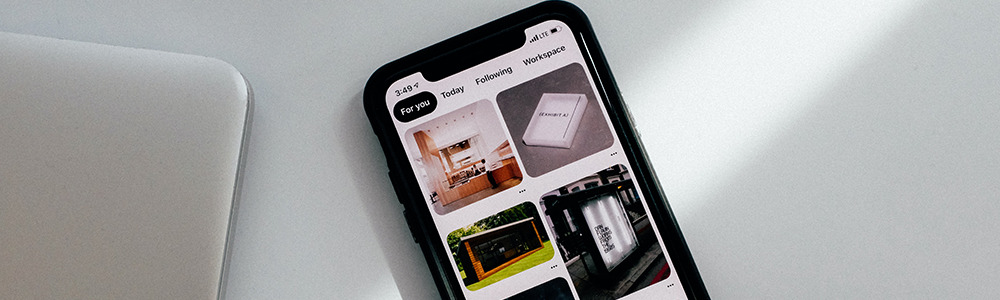Dallo studio dei recenti dati divulgati in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, è emerso quanto ancora le donne siano vittime di una disparità di genere che si manifesta trasversalmente in diversi ambiti.
Dalla sfera personale a quella pubblica, il mondo sembra fatto su misura per l’uomo mentre la donna resta subalterna agli eventi della Storia con la “S” maiuscola.
Abbiamo analizzato questo complesso e radicato meccanismo da vari punti di vista, cercando di chiarire importanti concetti quali gender-pay-gap, società patriarcale, femminismo, maternità, quote rosa e molti altri ancora.
Attraverso questa inchiesta, suddivisa in 5 articoli, ricercheremo e spiegheremo le
cause e gli effetti tangibili di una discriminazione sistemica che ha per vittime le donne di tutto il mondo.
È necessario in primo luogo comprendere quali siano le ragioni socio-culturali della disparità che affligge il genere femminile da secoli. Dalla violenza fisica e psicologica alle battute sessiste, ripercorriamo l’ordine degli eventi che ci hanno condotto ad una realtà che vede “l’uomo misura di tutte le cose”.
Ma in questa visione fallocentrica, la donna dove sta(va)?
Ma posso dire patriarcato?
A volte può accadere che, mentre discutiamo animatamente con gli amici di fronte ad una birra un venerdì sera o magari con perfetti sconosciuti su Clubhouse, salti fuori la parola “patriarcato” senza che spesso se ne conosca il reale significato. Il termine infatti è così poco chiaro alla maggior parte delle persone che si può definire un intero “spettro antropologico” di reazioni a seconda di quanto l’interlocutore sia più o meno informato (e più o meno misogino). A sentir parlare di patriarcato, c’è sempre qualcuno a cui trasale la birra. C’è poi chi reagisce indignandosi, chi lo tratta con superficialità o decide di ignorarlo, oppure chi ne polemizza l’utilizzo “a sproposito”, un po’ come se fosse prezzemolo.
Ma cosa si intende veramente per “cultura patriarcale”? E perché ne va accettata l’esistenza?
Diciamolo una volta per tutte: no, “patriarcato” non è una parolaccia, eppure parlarne o semplicemente citarlo genera ancora troppo sconquasso. Ciò dipende principalmente dal fatto che attorno al termine ci sia ancora molta disinformazione, causa primaria di fraintendimenti e negazionismi.
Solo comprendendone il significato sarà possibile capire quanto questo influisca su ogni aspetto della nostra vita, risultando penalizzante sia verso le donne che verso gli uomini.
Si definisce infatti patriarcato un “sistema sociale maschilista in cui gli uomini detengono principalmente il potere e predominano in ruoli di leadership politica, autorità morale e privilegio sociale”. Al giorno d’oggi però, questo termine (che ha origini ancestrali) si carica di concetti ed implicazioni socio-culturali ben più sottili, tanto da essere onnipresente (e per questo apparentemente invisibile) nella nostra quotidianità.
Nei secoli, il patriarcato si è manifestato nell’organizzazione sociale, politica, religiosa ed economica delle popolazioni, generando importanti effetti culturali di cui tutt’oggi siamo tutti vittime e, allo stesso tempo, abili prosecutori.
L’esistenza di un’ideologia patriarcale secolare ha implicato il radicamento di un’impostazione maschilista e misogina della realtà che si mescola costantemente con la nostra prassi quotidiana.
Non sappiamo come effettivamente il patriarcato sia nato, o meglio, sappiamo che è nato nel momento in cui l’essere umano ha iniziato ad organizzarsi in comunità ma possiamo solo speculare su quali siano potute essere le vere cause che hanno condotto l’uomo ad imporsi sistematicamente sulla donna, autoproclamandosi come “sesso dominante”.
Una delle ipotesi più valide è quella che si basa sulla teoria mimetica di René Girard, secondo cui in sostanza l’imitazione (la “mimesi” appunto) costituisce il fondamento dell’intelligenza umana e dell’apprendimento culturale che caratterizza ogni individuo (e come negarlo?).
Secondo Girard però, questo atteggiamento mimetico nei confronti della realtà non è solo una bonaria e candida assimilazione di ciò che ci sta intorno ma contiene in sé una potenza distruttrice. Negli individui appartenenti ad una stessa società si alimenta infatti una generalizzata fame di possedere gli stessi oggetti. Da ciò deriva quella “rivalità mimetica” che, molto spesso, sfocia in violente e caotiche crisi. L’unico modo per risolvere il problema e “mettere una pezza” sullo squarcio che si viene inevitabilmente a creare, è immolare un capro espiatorio a cui addossare la colpa così da poter garantire il ritorno della pace e la costruzione di una nuova cultura fondata su altrettanto nuove certezze.
Ed è proprio questa la storia del patriarcato, nato in risposta alla profonda crisi delle società agricole primordiali. Secondo la teoria mimetica, l’uomo ha quindi deciso di immolare l’essere femminile a vittima sacrificale, condannandola a diventare la peccatrice colpevole di tutto il “male” esistente (ci suona familiare, no?) e costruendo sulla “necessaria” discriminazione della donna un nuovo modello di società che tutt’oggi resiste: quella maschilista e patriarcale.
Ciò che molti non sanno (o si rifiutano di ammettere) è che quest’impostazione sessista, basata su uno squilibrio di potere, ha un effetto deleterio sia sugli uomini che sulle donne. Entrambi infatti sono schiavi di stereotipi di genere fasulli ed inarrivabili che li ingabbiano in modelli preconfezionati e claustrofobici in cui, il più delle volte, non si rispecchiano.
Negare l’esistenza di una cultura patriarcale che permea ogni ambito della nostra sfera personale e collettiva si rivela perciò tanto falso quanto controproducente: sessismo e maschilismo si manifestano continuamente nella nostra quotidianità in modo più o meno esplicito e negare questa evidenza non fa che alimentarne il meccanismo discriminatorio.
L’esistenza del gender gap, il drammatico numero di femminicidi (91 solo nel 2020, come riportato da Il Sole 24 Ore), la violenza di genere ormai prassi quotidiana (secondo l’istat, colpisce 1 donna su 3) e la disparità di salario sono solo la punta dell’iceberg degli effetti dell’ambiente patriarcale in cui viviamo. Oltre a queste evidenze drammatiche, tanto consolidate da costituire lo “status quo”, esistono poi decine di atteggiamenti discriminanti più sottili che vengono spesso percepiti come “tollerabili” o addirittura “innocui” dalla società e, per questo motivo, più difficili da combattere. Fanno parte di questa seconda categoria il catcalling e le battute sessiste e a sfondo sessuale che, mascherate dalla goliardia, rendono infelicemente esplicita la visione retrograda che ancora si ha della donna: ora come “angelo del focolare”, ora come oggetto sessuale e mercificato.
Insomma, sempre di Medioevo si parla. Ma non eravamo nel 2021?
L’atteggiamento discriminatorio che prevede che la donna occupi una posizione subalterna all’uomo si riflette in tutta la sua silenziosa violenza nell’uccisione dei femminili plurali. Il genere grammaticale del maschile plurale infatti ingloba e soggioga il femminile, riflettendo ciò che accade nella realtà. Ciò è testimoniato anche dal documento redatto dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, in cui si dice chiaramente quanto la lingua quotidiana sia il mezzo di trasmissione più pervasivo di una visione del mondo in cui la donna è trattata con inferiorità o marginalità.
É paradossale, ma basta un uomo in una platea di mille donne per permettere che si parli correttamente di “tutti” e non di “tutte”.
Ciò che spesso non capiamo è che ognuno di noi è il frutto sano (o marcio?) della società in cui vive. L’ambiente che ci circonda ci istruisce, fin da bambini e bambine, ad un sistema maschilista, iniquo e discriminante nei confronti delle donne in ogni aspetto della vita.
Perciò sì, anche le donne sono maschiliste. E come potrebbero non esserlo, se il maschilismo costituisce la norma?
In un mondo costruito su uno squilibrio di potere fatto passare per naturale ed immutabile e su una società che ci ingabbia in etichette tanto claustrofobiche da renderci immobili nella paralisi della nostra inettitudine, continuiamo a deresponsabilizzarci dalle nostre colpe e dalle capacità che abbiamo di cambiare le cose.
Ci ripetiamo: “Il problema è il sistema, non dipende da noi”, rassicurati dalla nostra innocenza mentre iteriamo gli stessi errori e le stesse discriminazioni, assuefatti dalla stasi di una pace fragile ma destinata a frantumarsi.
Un problema di linguaggio: forma e sostanza
Sottovalutiamo spesso il peso delle parole. Ci capita di continuo di utilizzare dei termini “per abitudine”, non riflettendo sul loro reale significato o sulla loro origine ed abbandonandoci così a comodi cliché che però si portano dietro una lunga storia di discriminazione o violenza.
Va avanti ormai da secoli la diatriba su cosa sia il linguaggio, sospeso tra la pura forma e la pura essenza. Basti pensare che già nel IV secolo a.C., Aristotele reputava che il linguaggio esprimesse l’essere, definendolo un “contenuto della coscienza”.
L’errore che spesso commettiamo è quello di fissare il linguaggio nello spazio e nel tempo, con un atteggiamento restio al cambiamento. Perché sì, sarebbe molto più comodo ancorarci all’hic et nunc per avere delle certezze, perlomeno quando parliamo, ma ciò ci rende miopi nei confronti di una società che sta mutando, ed anche molto velocemente.
Il vocabolario e la semantica associata alle parole sono sempre stati lo specchio dei valori e del grado di civiltà di una popolazione. I termini utilizzati in diversi contesti infatti sono la prima spia delle abitudini culturali e degli equilibri di potere che governano un popolo.
Alla luce di questo, potremmo rintracciare decine e decine di incongruenze nella nostra lingua che dovrebbero farci chiedere: voglio veramente dire quello che penso utilizzando queste parole?
Partendo dalla vastità degli appellativi offensivi con cui ci si riferisce alle donne (quasi sempre basati sulla denigrazione sessuale), la discriminazione che mettiamo quotidianamente in atto con il linguaggio si fa sempre più sottile. Questa infatti si manifesta continuamente, ormai completamente inglobata nelle nostre categorie di pensiero. Stiamo compiendo una violenza verbale ogni volta che diciamo che una donna è “isterica” o concordiamo con il lemma “donna” della Treccani, in cui il termine è definito come sinonimo di “cagna” (e poi ancora bagascia, squillo, puttana, vacca, zoccola..). In opposizione alla famosa Enciclopedia si muove la decisione dell’Oxford Dictionary, che sceglie invece di rivedere i sinonimi dispregiativi associati alla parola “donna” in quanto ritenuti inaccettabili. Siamo poi discriminanti e sessisti ogni volta che utilizziamo gli appellativi dispregiativi “maschiaccio” e “femminuccia” ma anche quando usiamo il maschile singolare o plurale invece che il femminile.
Durante l’edizione del 2021 del festival di Sanremo, è stata protagonista non solo la canzone italiana ma, come ormai è tradizione, anche la discriminazione di genere. Al di là dei presentatori e di alcuni siparietti che sul piano del sessismo hanno lasciato alquanto a desiderare, uno degli eventi più dibattuti è stato sicuramente il discorso della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che, alla domanda di Amadeus, risponde di voler essere chiamata “direttore”. Conduttore e ospite sono entrambi responsabili di aver rimarcato un’amara verità: il titolo è autorevole solo se al maschile, come se l’utilizzo del femminile ne comportasse uno svilimento professionale.
Tralasciando cosa ne pensi il vasto pubblico, occorre ribadire che in italiano è grammaticalmente corretto riferirsi al femminile quando si sta parlando di una donna. “Direttrice” perciò è un termine che non solo esiste ma è anche ben assodato nella lingua parlata. Perché allora porre lo scomodo interrogativo “direttrice o direttore?”, come se stessimo parlando di gusti di gelato?
Ora, poiché ognuno è libero di farsi chiamare come vuole, è giusto riferirsi alla Venezi come “direttore” dato che questa è la sua volontà. Ciò non giustifica però la grande ottusità che si cela dietro all’affermazione. Accade spesso infatti che, volontariamente (come in questo caso) o involontariamente, ci si riferisca a ruoli femminili utilizzando termini al maschile.
Le motivazioni che si celano dietro questa scelta sono molte ma in primis riguardano un retaggio culturale, dovuto al fatto che molti lavori sono stati per secoli accessibili solo a uomini. A ciò si aggiunge l’esistenza di una sorta di “imperativo maschile” sulle parole che fa percepire il femminile come subalterno, opzionale o inferiore.
La giustificazione spesso utilizzata quando si sceglie di non usare i termini femminili corretti è che questi risultano cacofonici, cioè “suonano male”. Il punto è che questo accade perché non li utilizziamo mai, e non li utilizziamo mai perché molti ruoli sono rimasti inaccessibili alle donne per secoli: ora che hanno conquistato i diritti per svolgere questi lavori (sebbene ancora con molti ostacoli), è nostro dovere chiamare le cose col loro nome.
Per cui, il “direttore” Venezi ha tutto il diritto di farsi chiamare come vuole ma ciò dimostra solo quanto lei stessa sia vittima di quel meccanismo patriarcale che soggioga la donna all’uomo, condannandola ad esserne un’ombra, una sbavatura, una parola che suona male.
Il sessismo intriso nella nostra cultura si riflette, senza che ce ne accorgiamo, nel modo in cui pensiamo e nel nostro linguaggio. Pretendere di non adattarci alle nuove dinamiche significa voler chiudere gli occhi ad un cambiamento propositivo e diretto verso una maggiore equità, sia formale che sostanziale.
Vera Gheno, sociolinguista e scrittrice, ritiene che sia fondamentale che la lingua evolva insieme ad un popolo in quanto ne è lo specchio dei meccanismi e delle dinamiche sociali.
Come la stessa Gheno spiegherà in un’intervista condotta da Tlon.it, è necessario valutare il peso sociale delle parole che utilizziamo ed il loro significato in relazione al contesto.
Abbiamo sempre avuto l’esigenza di nominare le cose e cambiamenti nel linguaggio non sono altro che la manifestazione di una cultura che si sta evolvendo.
Dobbiamo smettere di pensare che le parole siano solo parole: le parole sono ciò che ci rende umani.
Per Michela Murgia, scrittrice ed intellettuale sarda, la lingua è un atto creativo genuino che non può essere ingabbiato in stereotipi o modelli fissi e segue un continuo flusso di riadattamento. Il suo ultimo libro “STAI ZITTA e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” nasce proprio dall’esigenza di analizzare il linguaggio che utilizziamo, troppo spesso trattato con superficialità, e svelarne i meccanismi di potere (maschile) che vi si manifestano. La motivazione che l’ha spinta a scriverlo è arrivata quando il noto psichiatra Raffaele Morelli, dopo aver rilasciato dichiarazioni deplorevoli sulle donne (e sulla presunta esistenza di una “radice del femminile”), interrompe brutalmente Murgia dicendole “zitta, zitta, zitta e ascolta”. Cosa ha fatto Michela Murgia dopo essere stata pubblicamente umiliata? Scrive un libro per combattere quell’ignoranza e quella presunta superiorità di cui Morelli si è fatto paladino, e lo fa per tutti noi.
Lo studio condotto dalla Murgia pone ancora una volta l’accento sulle cause socioculturali di quelle discriminazioni di genere che si riflettono nelle parole che scegliamo di utilizzare.
In una delle interviste che ha condotto per la presentazione del libro ha come ospite Alessandro Giammei, professore di italianistica al Bryn Mawr College negli USA, con cui concorda nel dire che il linguaggio è sostanza, in quanto è il mezzo attraverso cui modelliamo la realtà. Per questo motivo, fissare la definizione di una parola nello spazio e nel tempo significa paralizzarla nella gabbia delle sue lettere.
Il patrimonio storico delle parole dovrebbe quindi essere costantemente rivisto in una chiave inclusiva e più rispettosa, secondo le esigenze della società.
Espressioni come “donna con le palle” sono dei comodi cliché che spesso utilizziamo senza cognizione di causa mentre invece dovrebbero farci inorridire. Sebbene siamo consapevoli di quanto questo sia un modo di dire svilente verso le donne, continuiamo ad usarlo perché riassume perfettamente la credenza comune secondo cui forza e coraggio sono qualità tipicamente maschili.
Il nostro compito allora è quello di trovare altre espressioni che mettano in risalto la forza o il carattere di una donna senza ricorrere ai genitali maschili. Fare questo adesso ci richiede uno sforzo, ma in futuro non lo richiederà più: solo allora avremo rinnovato il linguaggio.
Cambiare le parole infatti non significa altro che connotare la realtà in modo che ci somigli di più.
Sempre su questa linea si muove la proposta della Gheno per la costruzione di un linguaggio più equo ed inclusivo, anche in vista delle nuove soggettività non-binarie (la cui identità non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile): questo sarà possibile solo adottando nuove soluzioni, come l’asterisco al posto di i/e al termine delle parole (esempio: tutt* al posto di tutti/e) o una vocale neutra chiamata schwa(ə).
Come lei stessa spiega nel suo saggio “Femminili singolari”, la schwa corrisponde ad una vocale media-centrale ed è sostanzialmente il suono che emettiamo quando la nostra bocca è in rilassamento (per sentire il suono, cliccate qui). Si rappresenta con il simbolo ”ə” ed è il primo passo verso un italiano più inclusivo. Secondo la Gheno infatti, nel sistema-lingua possono “convivere sia le regole che un certo grado di libertà” affinché l’insieme sia funzionale e rispecchi l’anima di chi parla.
Al giorno d’oggi, esistono persone che si sentono ingabbiate nel binarismo di genere maschile/femminile ed è quindi necessario venire incontro anche a questa nuova esigenza sociale. La scelta della schwa si muove anche verso il raggiungimento della parità di genere nel parlato in quanto potrebbe sostituire quel “maschile sovraesteso” che nasconde il femminile quando ci si riferisce alle moltitudini.
Dato che continuamente assorbiamo e riadattiamo termini dall’inglese, cosa ci impedisce di aprirci a nuove alternative, svecchiando la nostra lingua?
Il linguaggio è (anche) sostanza e solo attraverso una narrazione più inclusiva, corretta, rispettosa e (quanto più possibile) libera da quel filtro cognitivo compromesso dall’ambiente socio-culturale in cui ogni individuo è cresciuto si può contribuire ad un effettivo cambiamento: la lotta comincia dalle parole e solo la curiosità potrà salvarci dalla paralisi del linguaggio.
Del perché il femminismo è roba da uomini
Data la grande confusione che si genera attorno al termine, ripetiamo che si definisce femminismo quel movimento socioculturale che sostiene la parità politica, sociale ed economica tra i sessi, rivendicando uguali diritti e dignità tra uomini e donne alla luce di quella discriminazione di genere ancora protagonista della nostra quotidianità.
Solitamente però, tendiamo a credere che il femminismo sia “roba da donne” o, peggio ancora, “l’antitesi del maschilismo” quando in realtà non è assolutamente così.
Se il maschilismo, come dice Garzanti, è quell’atteggiamento psicologico e sociale fondato sulla presunta superiorità dell’uomo sulla donna, il femminismo è invece un movimento trasversale nato proprio per opporsi a comportamenti e pensieri discriminanti ed ha come obiettivo principale quello di conquistare la giusta parità, indipendentemente dal sesso di appartenenza.
Ed è esattamente questo il motivo per cui dovremmo essere tutti femministi.
Lorenzo Gasparrini, filosofo e scrittore, si definisce orgogliosamente uomo femminista. Con i suoi libri “Non sono sessista, ma…” e “Perché il femminismo serve anche agli uomini” ci spiega perché la cultura patriarcale e l’ideologia maschilista siano deleterie tanto per le donne quanto per gli uomini. Gasparrini infatti mette nero su bianco una scomoda verità che molti si rifiutano di accettare: i “veri maschi” non esistono.
Quella che ci viene quotidianamente fornita è un’idea distorta di essere uomini, come se esistesse una sola versione di mascolinità che è possibile impacchettare e comprare al bar, insieme alle Haribo. É questa la “mascolinità tossica” che, secondo il New York Times, consiste in un insieme di comportamenti e credenze che comprendono il sopprimere le emozioni, mascherare il disagio o la tristezza ed utilizzare la violenza come indicatore di potere.
La società patriarcale promuove quindi un solo modello: quello dell’uomo-macho, virile, forte e superiore. Questo meccanismo li spinge (involontariamente) a conformarsi a quelle che sono fatte passare come le “tipiche qualità dell’uomo” quando in realtà sono le sbarre della gabbia che lui stesso si sta costruendo intorno.
Sebbene la sua sia una condizione decisamente più favorevole di quella femminile, anche lui è schiavo della stessa cultura misogina e maschilista che, se da un lato discrimina e oggettifica la donna, dall’altro impone una sola versione di uomo, quella “vera”, fatta di testosterone, maschilismo e sete di dominio.
Ed è così che il passo è breve per appellare un uomo gentile a “gay” (come se si trattasse di un’offesa), insultarlo perché “secco” o denigrarlo perché giustamente si occupa delle faccende di casa, per non parlare del “machismo da spogliatoio” che si verifica nel mondo dello sport.
Insomma, anche l’uomo è costretto nella prigione del suo sesso.
Negli ultimi anni, un caso esemplare che ha fatto esplodere la “bolla di vetro” satura di mascolinità tossica e distinzioni di genere è stato Achille Lauro. Il cantante e showman nella scorsa edizione di Sanremo ha sconvolto il pubblico della TV popolare attraverso comportamenti e dichiarazioni decisamente fuori dagli schemi. Per Lauro, è la confusione dei generi il suo personale modo di dissentire ad una realtà maschilista e rifiutare quelle convenzioni da cui poi si generano discriminazione e violenza. Questo approccio alla vita si riflette nel linguaggio, nelle azioni e nell’apparenza, intesa come modo di vestirsi e di mostrarsi.
Sempre sul palco dell’Ariston quest’anno è stata Madame, artista giovanissima e di immensa consapevolezza, a rompere un bel po’ di schemi. Nelle sue canzoni, tra le altre cose, emerge la necessità genuina di una fluidità in grado di riportarci ad essere carne ed anima, ad essere persone prima di “maschi” e “femmine”, diventati ormai concetti sterili e fini a se stessi.
Il primo passo per demolire e superare questo sistema divisivo e discriminante è perciò ammettere di essere il prodotto ben riuscito di una cultura patriarcale di cui abbiamo interiorizzato gli schemi. Solo dopo aver raggiunto questa consapevolezza sarà possibile liberarci da quei claustrofobici stereotipi che costituiscono la “norma”.
Certo, lottare contro i modelli sociali, le abitudini culturali e gli elementi linguistici discriminanti con cui siamo cresciuti fin dall’infanzia è un processo faticoso (almeno inizialmente) ma solo così potremo costruire una società più giusta ed inclusiva.
Nasciamo tuttə maschilistə ma dovremmo diventare tuttə femministə.