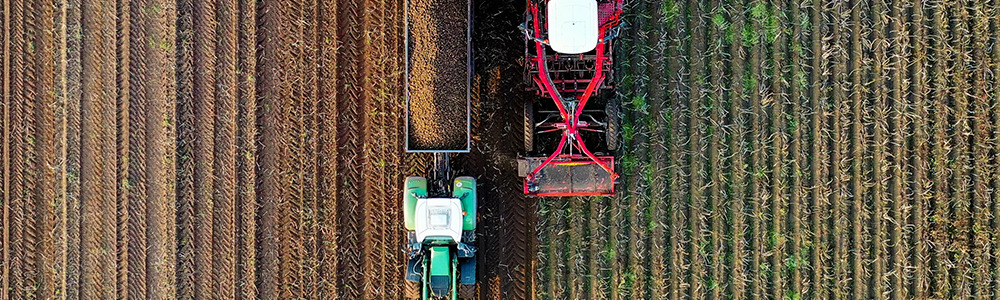Qual è la situazione del food delivery in Italia?

Alzarsi dal divano, aprire il frigo per preparare la cena agli ospiti che arriveranno tra poco e accorgersi che mancano due ingredienti fondamentali. Un tempo avremmo fatto una brutta figura, oppure una corsa disperata al supermercato più vicino sperando di trovare ciò che ci serviva e fare in tempo a cuocere tutto. Oggi, in massimo mezz’ora, questi ingredienti ci vengono recapitati direttamente a casa, con due click sullo schermo dello smartphone: l’arte del food delivery.
Breve storia del food delivery
La possibilità di veder recapitato il cibo pronto a casa in un tempo ragionevole non è sicuramente una grande novità.
Il concetto parte dal cibo d’asporto di cui, una prima forma rudimentale si ha traccia dai cosiddetti dabbawala a Mumbai nel lontano 1890. Considerabile la prima azienda di consegne a domicilio, il termine tradotto dall’hindi significa proprio “colui che porta una scatola”. Il concetto si diffonde poi in occidente all’inizio del ‘900 che rende inevitabile, per tutte le classi di lavoratori che iniziarono ad esercitare la loro professione sempre più lontano da casa, avere dei pranzi d’asporto.
Dopo la Seconda guerra mondiale, la pratica si è diffusa oltreoceano e i ristoranti, per incrementare le vendite, cominciarono a pubblicizzare nella appena nata televisione la possibilità dei menù take away. Uno dei primi cibi facilmente “portati a casa” è stata proprio la pizza. Arrivando all’Italia il servizio delle consegne a domicilio si è sviluppato grazie all’impulso delle prime attività che effettuavano vendite per corrispondenza tramite cataloghi come la milanese Postal Market, fondata nel 1958. Successivamente l’abbiamo sempre associato al fattorino della pizza che ad oggi, ogni weekend imbandisce le tavole di milioni di italiani con delle calde pizze appena sfornate
Dobbiamo tuttavia aspettare il 1994, anno in cui, una pizzeria della catena Pizza Hut a Santa Cruz in California aprì un sito web dove era possibile ordinare la pizza online, creando di fatto il primo esempio di e-commerce al mondo.
Ad oggi le possibilità sono aumentate: non più solo cibo pronto, ma si può richiedere anche la spesa di ogni genere e prodotti farmaceutici, in un tempo sempre minore e in modo sempre più capillarizzato per le città. I motivi per cui si sceglie di farsi recapitare il cibo a casa sono molteplici: secondo un’indagine di Just Eat, ai primi posti ci sono: mancanza di tempo, comodità di non dover uscire di casa, poter provare diversi piatti facilmente e nella propria abitazione.
Il valore complessivo del mercato del digital food delivery a fine 2020 si aggirava intorno agli 800 milioni di euro, e si stima che nel 2021 possa raggiungere la quota di 1 miliardo. I maggiori player attualmente presenti sul nostro territorio sono: Just Eat, Uber Eats, Deliveroo e Glovo.
Proprio di quest’ultimo, abbiamo seguito una presentazione ai Digital Innovation Days.
Glovo ai Digital Innovation Days: i racconti dietro le quinte
Al webinar ha parlato Agustina Clair: Head of Q-Commerce, Food Innovation & GlovoLastMile presso Glovo, l’app che delivera quello di cui hai bisogno.
Ha spiegato che attualmente, in Italia, sono secondi solo a Just Eat, il loro obiettivo è quello di arrivare in tutte le città con più di 25 mila abitanti entro dicembre. Agustina ha presentato un dato interessante: ben il 53% dei millennials che hanno provato a fare acquisti tramite sito di e-commerce, ha lasciato il carrello se non ha trovato il same day delivery, dato che fa ben capire cosa stia diventando il quick commerce.
In futuro, infatti, si prevede una velocità del servizio sempre maggiore, con consegne di 10 minuti, e proprio per questo motivo, Glovo sta aprendo diversi dark stores, una sorta di micro-magazzini cittadini che permettono di avere sempre tutte le merci a disposizione in locale e nell’immediato, così da avvicinarsi maggiormente al consumatore.
L’obiettivo della startup spagnola è sempre più ambizioso: riuscire a fare retail di tutti i prodotti necessari: dal fruttivendolo ai supermercati, fino alle farmacie e i bar. Proprio a questo scopo stanno mettendo in atto collaborazioni con diversi brand come Magnum, Durex e Unilever, diventando un nuovo canale di vendita per grandi marchi.
Il delivery e il Covid-19
Com’è immaginabile e come racconta la country manager di Glovo: “è brutto dirlo, ma per noi il Covid è stata la più grande campagna di marketing” e i dati lo confermano: il delivery durante la pandemia non si è di certo fermato, bensì è incrementato, data la crescente necessità di avere dei prodotti nonostante restrizioni e quarantene. Glovo, così come altri player ha continuato a consegnare anche quando le merci scarseggiavano e le code ai supermercati si facevano di due ore. L’abitudine di ordinare non si è persa con l’allentamento delle restrizioni, anzi il panel di consumatori ha continuato ad aumentare e dal 2020 non si è ancora arrestato. Si può dire che la pandemia ha aumentato l’awareness delle persone verso la possibilità di ordinare i prodotti da far arrivare a casa.
Non solo grandi player: ecco i “piccoli italiani” presenti sul nostro territorio
I grandi leader di settore citati precedentemente, non sono gli unici presenti, molte, anche se in misura minore, sono le startup Made in Italy con le loro vantaggiose peculiarità: maggiore sostenibilità, presenza in luoghi che i grandi player spesso lasciano in secondo piano, la valorizzazione del prodotto tipico e il rispetto per i riders.
Tra questi troviamo Alfonsino: la startup, nata a Caserta nel 2016, che ha come mission il portare il food delivery nei piccoli centri abitati soprattutto del sud Italia, zone normalmente lasciate indietro dai big player che puntano ai ricavi e alla facilità di consegna dati dalle grandi città dense di potenziali clienti. La startup campana ha chiuso il 2020 con ricavi da 3 milioni di euro e i suoi numeri parlano chiaro: circa 300 piccoli centri abitati serviti in sette diverse regioni, 950 ristoranti affiliati e 250mila utenti attivi sulla piattaforma.
Assieme ad Alfonsino, startup italiane come: Mymenu, Foodracers, Giusta e Cocai Express, quest’ultima nata dall’idea di quattro ragazzi veneziani per portare il food delivery nella Serenissima, si stanno espandendo sempre di più, per far arrivare questa forma di consumazione in tutto lo Stivale valorizzando l’eccellenza italiana.
Criticità dietro il food delivery: la sicurezza dei riders e la questione igiene
Dietro al food delivery sono presenti delle criticità che spesso vengono sollevate dai media: in primis la questione dei riders.
Ad oggi, non tutti sono tutelati come la legge italiana prevede, in quanto non riconosciuti come dipendenti bensì come lavoratori autonomi. Senza assistenza nè assicurazione, lavorando a cottimo, i professionisti di questo settore rischiano tanto, tutti i giorni, soltanto per offrire un servizio, a detta di molti, “non indispensabile e dettato dalla pigrizia”.
La situazione è peggiorata con la pandemia in quanto molte delle multinazionali precedentemente citate non forniscono ai loro collaboratori su due ruote, nemmeno la mascherina per proteggersi dal Covid-19, situazione che li ha portati a scioperare lo scorso marzo.
Il quadro peggiora se si pensa che i ciclofattorini vivono ogni giorno una condizione simile ad uno Squid Game della vita reale: turni anche di 15 ore per soli 20 euro, rischio altissimo di incidenti mentre si vola nel traffico, “controllati” da un algoritmo che li posiziona in un ranking e se l’ordine dovesse andare male per qualsiasi motivo anche non dipendente dal lavoratore, la piattaforma segnala l’errore e questo ha serie ripercussioni.
Come se non bastasse, un nuovo incubo si è aggiunto: le rapine subite a causa del GPS. In alcune località si sono verificati dei veri e propri furti di soldi e mezzo di trasporto dei riders che sono stati seguiti e circondati.
Presto, tuttavia, queste piattaforme dovranno sistemare i conti: il Procuratore di Milano ha chiesto la regolarizzazione contributiva e dei contratti di 60 mila riders in tutta Italia.
Un’altra dubbia questione riguarda l’igiene di questi cibi trasportati. Un’indagine di Altoconsumo in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha rivelato che: “al momento dell’ordine, risulta piuttosto complesso, se non a volte impossibile, individuare la presenza di allergeni nei menù: nel 25% dei casi non è presente una lista di ingredienti utilizzati per le ricette, nell’85% non è possibile deselezionare gli ingredienti e solo due ristoranti evidenziano gli allergeni sul menù della piattaforma come previsto dalla legge. Sui 60 ordini, eseguiti in fase di test, in cui si è provato a segnalare le allergie a uova e soia, è stata rilevata comunque la presenza di questi prodotti, come ingredienti o in tracce per contaminazione, 18 volte. Come se non bastasse, Al momento della consegna, è stata analizzata la temperatura degli alimenti. Per una corretta conservazione, si consiglia che i piatti freddi non superino i 10°C e i caldi non dovrebbero scendere sotto i 60°C. Meno problematici i piatti caldi, che in 1/3 dei casi sono arrivati a destinazione ad una temperatura superiore ai 60°C. Tutt’altro che buoni, invece, i dati sui piatti freddi: la temperatura media delle consegne rilevata è di 23.5°C arrivando fino ad oltre 30°C in due ordini. Quanto a sicurezza microbiologica, nel 38% dei casi non è stata raggiunta la sufficienza”
Dove si sta andando: ristoranti online e sempre più veloci
La prossima generazione di food delivery sarà probabilmente quella in cui il ristorante si “dematerializza”, diventando totalmente virtuale (il metaverso di Zuckerberg giocherebbe un ruolo fondamentale), i cibi potrebbero essere preparati nei dark stores e consegnati dai riders, vivendo l’esperienza con un visore indosso.
Scenari distopici a parte, quello su cui si sta puntando parecchio, nonché business model del nuovissimo player Gorillas, è proprio la rapidità di consegna. Gorillas, fondata a Berlino solo un anno fa, è diventata famosa per essere la startup più veloce di sempre in Europa a raggiungere lo status di Unicorno (startup che raggiungono la valutazione di mercato di un miliardo di euro), ma soprattutto per la sua capacità di recapitare la spesa in dieci minuti contati.
La realtà, appena sbarcata in Italia, si sta capillarizzando velocemente, continuando ad assumere un esercito di riders pienamente tutelati. Per far ciò si basa su un’infrastruttura per la consegna più rapida di prodotti essenziali nell’ultimo chilometro. Gli utenti dell’app hanno accesso a oltre un migliaio di prodotti essenziali agli stessi prezzi del supermercato per una tariffa di consegna di 1,80 €. Le metodologie e tecnologie necessarie per il quick commerce di Gorillas sono: il modo con cui viene costruito il layout del magazzino, l’app usata internamente e l’app per i bikers che consente loro di avere sempre i tragitti più brevi e una comunicazione rapida con il cliente.
In futuro probabilmente continueremo a battere i record di consegna più rapida, e mentre aspettiamo il rider contando i secondi che sono passati da quando abbiamo ordinato sull’app, troveremo il tempo di chiederci se tutta questa velocità ci serve davvero?
Autore
Beatrice Mula
Studentessa al primo anno di scienze e tecniche psicologiche, iscritta al percorso platinum del ciclo 10.0 di iBicocca con l’obiettivo di ampliare i suoi orizzonti.
Insaziabile curiosa e avida lettrice si interessa di molti ambiti dallo sport al digital, dalla scienza all’innovazione fino alla cultura nella sua interezza.
“Never stop learning” come motto, nel tempo libero fa divulgazione su TikTok