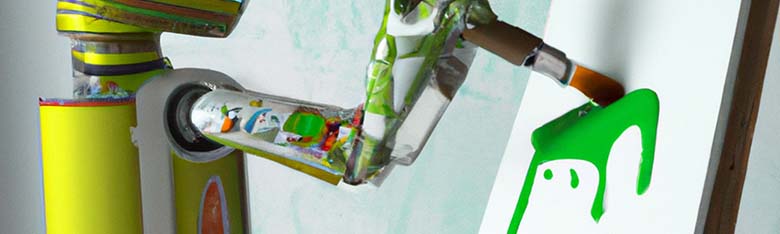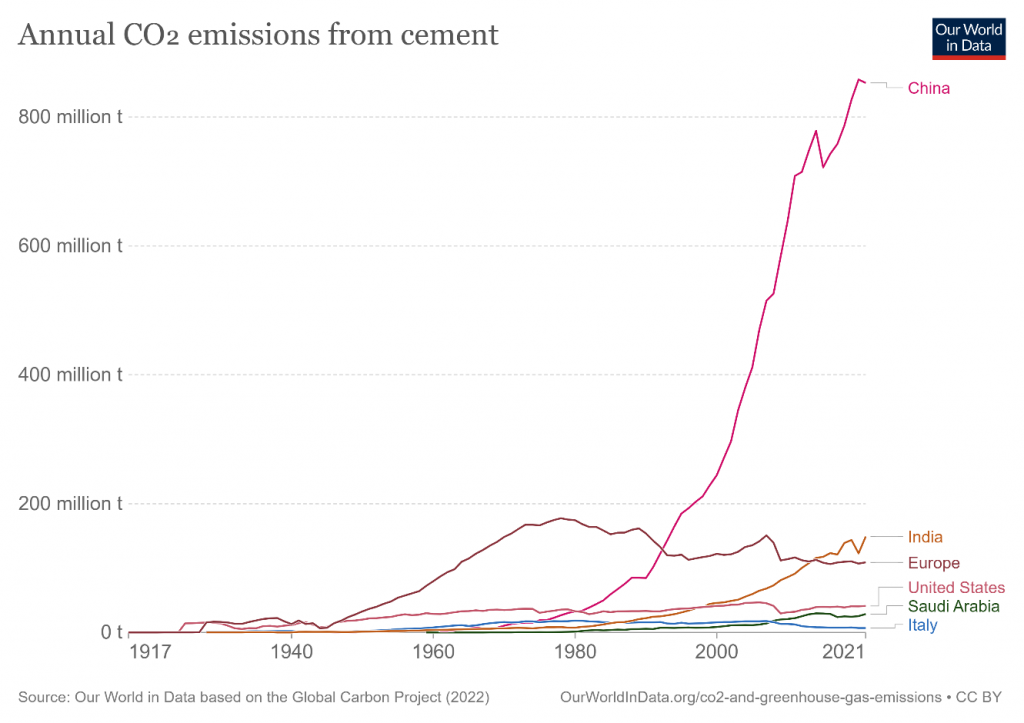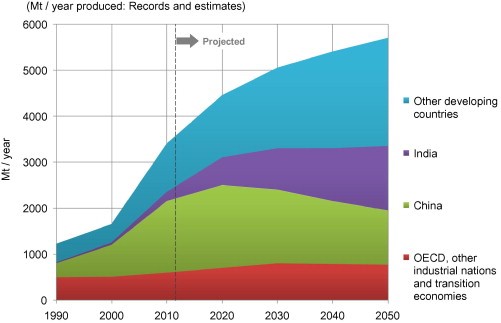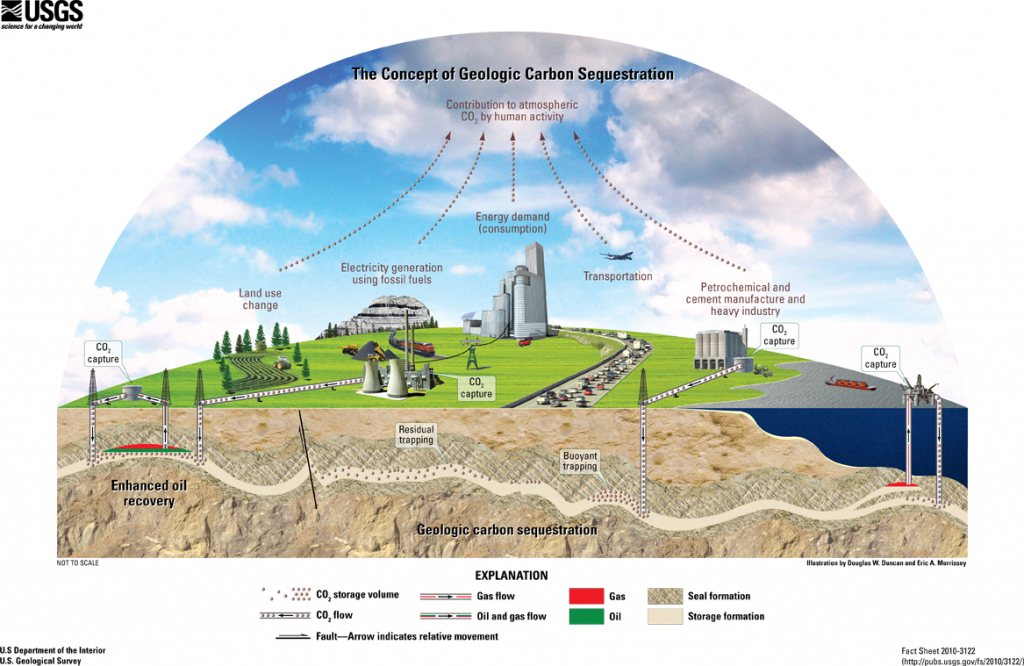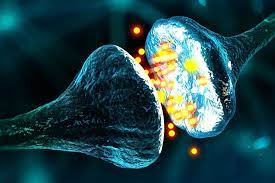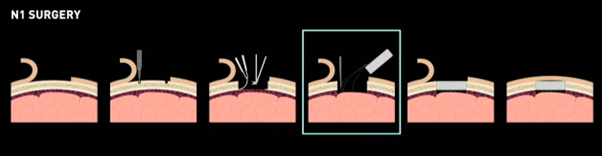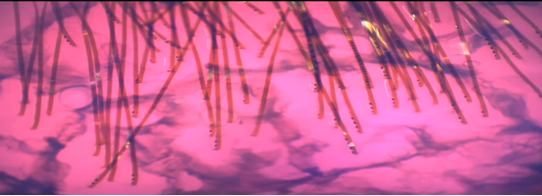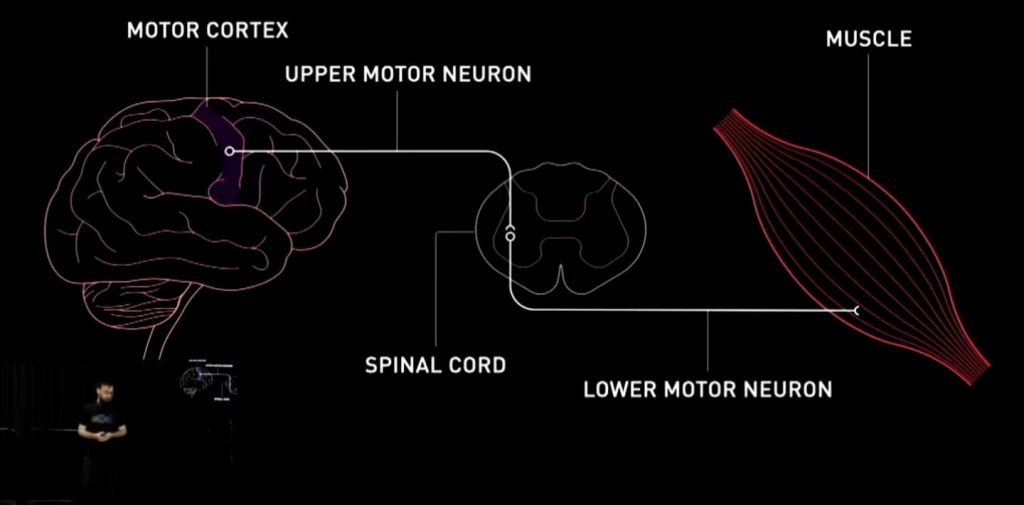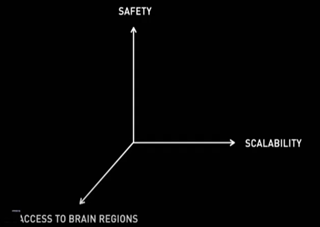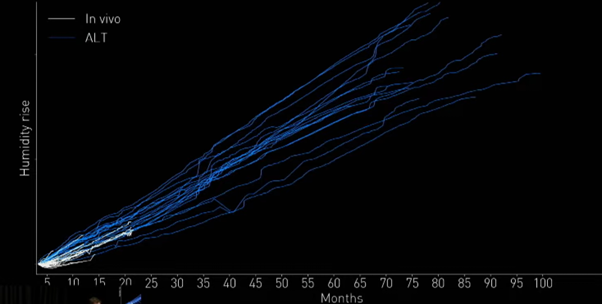Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i lavori creativi
Che l’intelligenza artificiale sia già largamente presente nelle nostre vite è evidente: basti pensare agli assistenti vocali, tra cui Siri, Cortana, Google Assistant e Alexa, ai marketplace online come Amazon, che in base al nostro comportamento online è in grado di capire a quali prodotti potremmo essere interessati e indirizzarci al loro acquisto, alle piattaforme streaming come Netflix, che, sempre in base alle azioni che effettuiamo sulla piattaforma, impara quali sono i contenuti di nostro gradimento per proporcene di simili e agli assistenti alla guida (ADAS) – presenti sulla maggior parte delle vetture oggi in commercio – i quali aiutano a prevenire gli incidenti. Proprio a partire da questi ultimi si evolve la guida autonoma, il cui graduale perfezionamento spinge il mondo a interrogarsi sull’impatto che questa avrà in futuro sui trasporti, nonché sulle problematiche che potrebbe generare nel mondo del lavoro se andasse a sostituire gli autisti di taxi, mezzi pesanti e mezzi agricoli. Questo interrogativo si inserisce in un dibattito più ampio, che, in tempi recenti, ha iniziato a interessare anche i cosiddetti lavori creativi; oggi, infatti, si può chiedere ai vari sistemi in circolazione – tra cui ChatGPT, Midjourney, Dall-e, Crayon, Imagen ed altri – di scrivere testi o generare immagini a partire dalle richieste degli utenti. Ma che cosa sono di preciso i lavori creativi?
Con il termine “creativi” si indicano tutti quei lavori riconducibili alla capacità espressiva dell’individuo, come il grafico, il fotografo, il designer e in generale l’artista. Tra i fattori che hanno contribuito a dare risonanza mediatica al dibattito sulla sostituibilità di queste figure da parte dell’intelligenza artificiale, significativo è stato il disclaimer che ha accompagnato ad aprile 2022 il lancio del servizio Dall-E 2 da parte della società OpenAI (che ha lanciato anche ChatGPT), il quale, tra le altre cose, afferma che “il modello potrebbe aumentare l’efficienza nell’esecuzione di alcuni compiti come l’editing o la produzione di fotografie d’archivio, che potrebbe soppiantare il lavoro di designer, fotografi, modelli, editor e artisti”. Allo stesso modo, tra gli altri eventi, ha creato preoccupazione nel settore la vincita di un concorso artistico negli Stati Uniti da parte di un quadro prodotto con Midjourney (“Théâtre D’opéra Spatial”).
Il mondo degli artisti è diviso sulla questione: una parte vede con scetticismo l’avvento di strumenti come Dall-E e Midjourney, l’altra al contrario apprezza queste piattaforme, in quanto ritiene che siano in grado di trasformare operazioni fino a ieri laboriose e che richiedevano precise competenze per essere svolte, in operazioni alla portata di tutti. Di questo parere è, ad esempio, lo scultore canadese Benjamin Von Wong, che afferma di non saper disegnare e dunque di affidarsi a Dall-E – dove basta inserire una stringa di testo per vedere realizzata l’immagine che si desidera – per visualizzare idee che successivamente trasformerà lui stesso in sculture.
L’utilizzo creativo dell’intelligenza artificiale non riguarda però solo il singolo artista nel processo di creazione di un’opera, bensì anche un altro ambiente dove l’AI è già largamente utilizzata per svolgere svariate operazioni: l’azienda. Questa, a seconda del tipo, ospita al suo interno diverse mansioni creative, per ciascuna delle quali esiste o sta nascendo una risposta del tutto digitale.
Nel caso degli organi di informazione, alcune testate giornalistiche tra cui Forbes e il Washington Post si affidano a strumenti come Heliograph e Synthesia per l’individuazione delle notizie di tendenza, l’ottimizzazione delle immagini e la stesura di titoli, altre come il DailyMirror e Express pubblicano articoli redatti dall’IA o vi inseriscono immagini da questa generate (più economiche rispetto a quelle di un fotografo), mentre altre ancora, tra cui Wired e Slow News, hanno scritto policy che impediscono a loro stesse di ricorrere a immagini o articoli frutto dell’IA. Alla base di quest’ultima decisione stanno ragioni di carattere etico, infatti, scrive Wired: “Vogliamo essere in prima linea nell’uso di nuove tecnologie, ma anche farlo in maniera etica e con una certa attenzione”.
A vedere la presenza sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale in chiave creativa è anche l’area marketing. La piattaforma Contents.com è in grado di ricoprire diverse delle mansioni tipiche del social media manager, promettendo di “generare qualsiasi tipo di contenuto in pochi secondi” e, basandosi su un approccio data driven, dichiara di poter produrre qualsiasi tipo di testo – dalle schede prodotto ai post per social media, dai siti web agli e-commerce – e ha già collaborato con diversi marchi noti, come Ikea e Allianz. Ghost Writer AI viene utilizzato dalla casa di videogiochi Ubisoft per scrivere i dialoghi tra personaggi non giocanti. Ad aprile 2023, Levi’s ha annunciato la collaborazione con la startup olandese Lalaland per la realizzazione di avatar iperrealistici generati dall’intelligenza artificiale che saranno utili a presentare i prodotti rispecchiando più fedelmente le caratteristiche dei consumatori. Uno dei casi più eclatanti è, infine, quello di Beck’s, che a breve metterà in commercio in edizione limitata la birra Autonomous, interamente sviluppata dall’IA; in particolare, Beck’s si è affidata a ChatGPT e Midjourney per la creazione della ricetta, del branding e della campagna marketing a supporto della birra, mettendo tutte le scelte in mano alla tecnologia. Sebbene si tratti di un prodotto ideato per celebrare il 150esimo anniversario dell’azienda, è chiaro che questo progetto contribuisca a segnare la strada per un futuro sempre maggiore coinvolgimento dell’IA nei piani aziendali anche per i ruoli creativi; non a caso, Beck’s ha annunciato che introdurrà nel corso del 2023 nuovi design per i suoi pack disegnati collaborando con sistemi come quelli già citati.
I casi fin qui analizzati ci mostrano come l’intelligenza artificiale sia destinata a divenire sempre più parte integrante delle professioni creative, con la conseguente necessità per le autorità pubbliche di intervenire normativamente laddove questo fenomeno possa creare problemi (ad es. deep fake, diritto d’autore…) e per coloro che svolgono lavori creativi di possedere le conoscenze base tecnologiche, di programmazione e di analisi.
Ad ogni modo, fino al momento in cui sarà possibile “insegnare la creatività ai computer” – qualcosa che il dottor Stephen Thaler ha tentato di fare con DABUS (sistema che ha dato vita autonomamente a due idee di prodotti dopo essere stato “allenato” dall’umano) – la capacità di guardare fuori dagli schemi, il senso critico e la motivazione ad approfondire un aspetto della realtà invece che un altro saranno prerogative dell’umano, che darà l’input all’intelligenza artificiale affinché trasformi il pensiero in realtà.