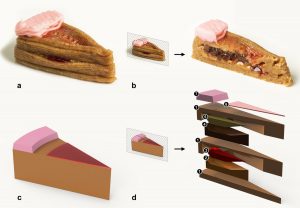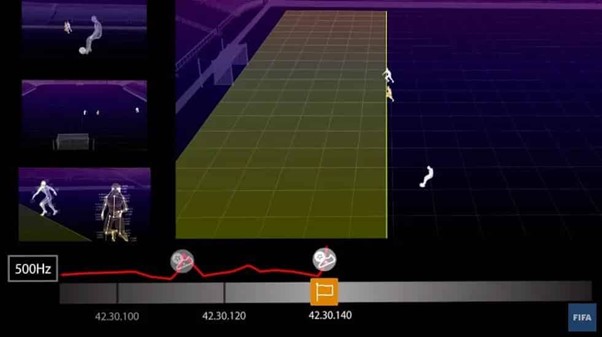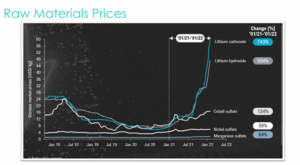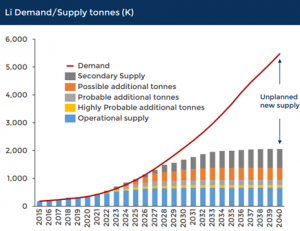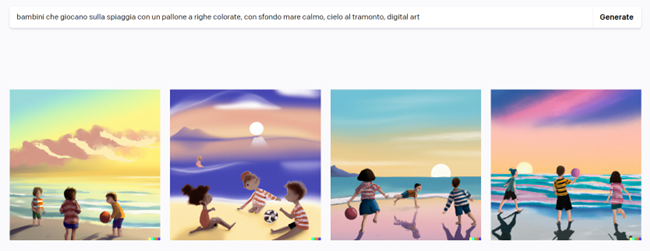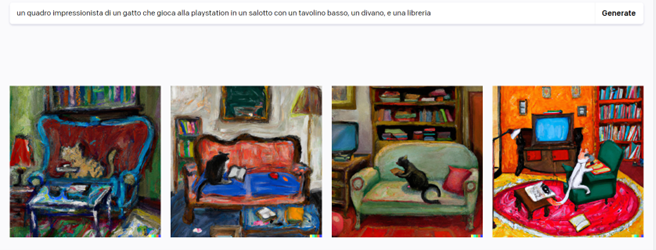Come sono andati i primi giorni del multimiliardario sudafricano alla guida del social network.
Dopo mesi di conferme e smentite, il 28 ottobre Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha acquistato Twitter con un accordo da 44 miliardi di dollari. Sono così iniziate due settimane di tweet controversi, licenziamenti a sorpresa e retromarce pittoresche che stanno raccontando molto di cosa abbia in testa il nuovo proprietario. Ripercorriamo insieme le tappe principali della vicenda, considerato che giorno dopo giorno i fatti si accumulano e gli orizzonti son sempre meno chiari.
I primi giorni
Il primo atto è andato in scena il 27 ottobre, e gli ingredienti sono stati la spettacolarizzazione e la comunicazione non intermediata, ovviamente via social: Musk si è presentato teatralmente presso la sede di Twitter con un lavandino (https://twitter.com/elonmusk/status/1585341984679469056), giocando in un tweet con l’espressione “let the sink in” (letteralmente “lascia entrare il lavandino”, ma che significa anche “digerisci la notizia”). Per l’annuncio dell’acquisizione ufficiale l’imprenditore di origine sudafricane ha poi pubblicato un post molto chiaro: “The bird is freed” (l’uccellino è stato liberato”), cambiando anche la propria biografia sul social network in “Chief Twit”.
Sin dai primi giorni il terreno di discussione (o faremmo meglio a dire “scontro”) su cui Musk si è mosso riguardavano due topic che affliggono da sempre il social network finanziato da Jack Dorsey: le precarie condizioni economiche in cui si trovava la società, sempre più evidenti negli ultimi anni, e la moderazione dei contenuti, ritenuta dal nuovo proprietario eccessiva e d’ostacolo alla libera espressione. Per segnare un cambio di passo e probabilmente dare un messaggio al mercato, Elon Musk ha scelto di inaugurare il nuovo corso con una serie di licenziamenti eccellenti, che hanno coinvolto fra gli altri Ned Segal, direttore finanziario, e Vijaya Gadde, avvocata a capo della squadra legale di Twitter e della divisione trust and safety che si occupa della moderazione, ma soprattutto Parag Agrawal, il CEO. La cosa curiosa è come siano andati i licenziamenti: i dirigenti allontanati, pur ricevendo una cospicua liquidazione, sono stati addirittura scortati fuori dalla sede come impiegati qualsiasi.
Metodi spicci ma che hanno subito dato l’imprinting a una governance che sembra promettere più pugno di ferro che morbida comprensione.
La questione delle spunte blu
Come accade su diversi social network, Twitter è in grado di verificare l’identità di persone e aziende di interesse pubblico per evitare il fenomeno dei fake account. Per distinguerli viene assegnata una spunta blu: un modo per riconoscerli come affidabili.
Una spunta blu veniva riconosciuta anche a chi decideva di avvalersi del servizio premium “Twitter Blue”, disponibile dal 2021 negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Oltre al badge “verified”, la versione premium di Twitter permetteva di postare video di maggior durata, visualizzare meno pubblicità e apparire per primi nei risultati di ricerca.
È su questa particolare feature che nel disegno di Musk si poteva sviluppare una nuova linea di revenue: l’idea del multimiliardario era far diventare le spunte blu solo a pagamento. In effetti, il 31 ottobre viene annunciato questo passaggio, ma non mancano i momenti “pittoreschi” in un’iniziativa che apparentemente non sembra poggiarsi su alcun tipo di riflessione. Parlando della cosa su Twitter, il founder di Tesla si è trovato a gestire una sorta di contrattazione con lo scrittore Stephen King (https://twitter.com/StephenKing/status/1587042605627490304), di fatto abbassando il prezzo di partenza da 20 dollari mensili a 8.
Una policy di pricing perlomeno curiosa, considerato che parliamo di un social network da più di 300 milioni di persone.
La nuova era
I colpi di scena però non finiscono qui.
Il primo novembre Musk ha sciolto il consiglio di amministrazione e ha nominato sé stesso come unico membro identificandosi come CEO.
Giovedì 3 novembre tutti i dipendenti di Twitter hanno ricevuto una mail in cui si comunicava che dal giorno successivo sarebbe iniziato un processo di “riduzione della forza lavoro”: se avessero ricevuto la comunicazione nella casella personale sarebbero stati fra gli esuberi, se invece fosse arrivata all’indirizzo aziendale il posto sarebbe stato salvo.
Potrebbe sembrare uno scherzo, ma il giorno successivo, venerdì 4 novembre, effettivamente circa metà dei 7500 dipendenti è stata licenziata. Una tempestività non solo difficile da comprendere dal punto di vista umano, ma anche legislativo: non sono stati nascosti i malumori sia del governo della California (le leggi dello stato prevedono in questi casi un periodo di preavviso di almeno 60 giorni) sia degli inserzionisti, visto il trattamento decisamente poco comprensivo. Non sono mancati poi problemi nell’organizzazione interna, dato che molte delle risorse allontanate erano operative in attività indispensabili per la quotidianità di Twitter. Si parla di intere divisioni praticamente azzerate, tra cui quella che si occupava della moderazione dei contenuti.
Una scelta avventata, sconfessata pochi giorni dopo dalla stessa nuova leadership di Twitter: alcuni dipendenti, licenziati appena tre giorni prima, sono stati richiamati in servizio. All’origine del contrordine ci sarebbe stata una verifica sui criteri di valutazione da parte dell’azienda, che solo dopo aver dato il via ai licenziamenti avrebbe evidenziato la necessità di disporre di alcune specifiche competenze. Inoltre, erano stati evidenziati errori formali: alcune persone sarebbero state licenziate per errore.
Lo scenario sembrerebbe essere disastroso.
In effetti, per cercare di arrestare l’emorragia di malumore, mercoledì 9 novembre, durante una diretta su Spaces (le “stanze” dove discutere di Twitter), Musk ha provato a tranquillizzare gli investitori assicurando che verranno introdotte nuove funzionalità che miglioreranno la qualità dell’esperienza utente: a suo avviso, la richiesta di pagamento per ottenere la spunta blu porterebbe da una parte all’aumento degli introiti dell’azienda, e dall’altra scoraggerebbe la creazione di account fittizi.
Una spiegazione che però non ha contribuito a prendere decisioni perlomeno curiose. Nella sua prima mail ufficiale ai dipendenti, l’imprenditore ha comunicato a tutti i dipendenti sarebbero dovuti tornare in ufficio dal giorno successivo, concludendo l’opportunità di lavorare da casa che, nell’ultimo contratto sottoscritto dall’azienda, era stata definita come condizione permanente. Il giorno seguente, giovedì 10 novembre, Musk ha poi convocato una riunione con il personale con una sola ora di anticipo per annunciare che Twitter perderà nel futuro diversi miliardi di dollari e per ribadire la necessità di tornare in ufficio “a meno che sia fisicamente impossibile”.
I problemi però, al netto dello smart working abolito, non sembrano esser scomparsi. Alcuni possessori di Twitter Blue hanno finto di essere qualcun altro: per citare un solo esempio, un account premium si è finto l’azienda farmacologica Eli Lilly e ha annunciato che “l’insulina sarà gratuita”, con conseguenze reali in borsa.
L’imprenditore ha twittato che “Twitter farà molte cose stupide (traduzione letterale ndr) nei prossimi mesi. Manterremo ciò che funziona e cambieremo ciò che non funziona” (Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn’t), andando così a delineare quello che pare essere la direzione di Elon Musk: sperimentare e cambiare continuamente.
Così è accaduto alla spunta grigia con dicitura “Ufficiale” che doveva aiutare a riconoscere i profili verificati da quelli premium: è stata lanciata e ritirata in meno di ventiquattro ore.
Tutto questo è capitato in meno di un mese. Se c’è una cosa che è sicura, è che Twitter sotto la gestione di Elon Musk non sarà noioso!