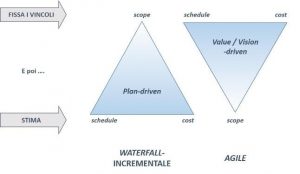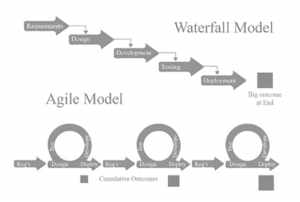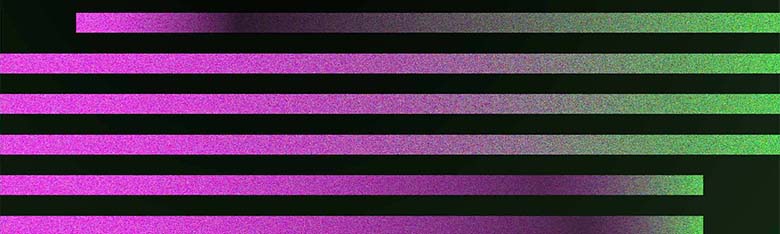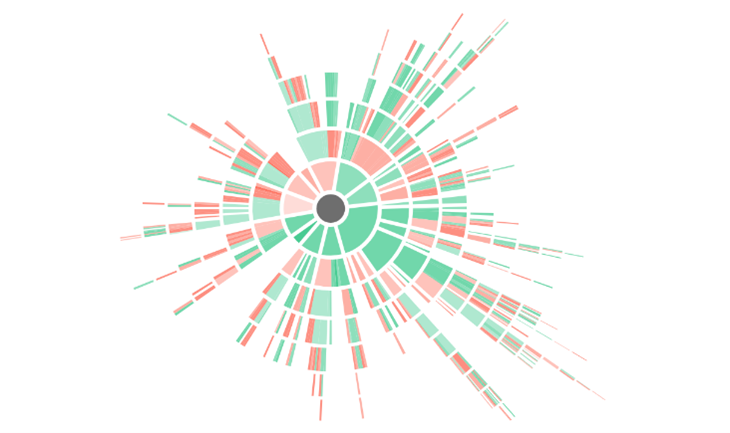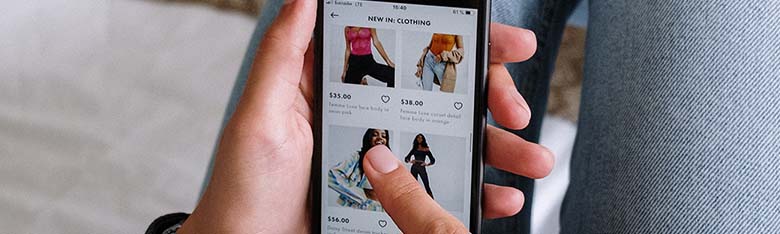iBicocca Titanium: il percorso di pre-accelerazione firmato UniMiB
Alla scoperta del nuovo percorso complementare fornito gratuitamente da iBicocca, progetto di UniMiB, per supportare idee imprenditoriali di studenti, ricercatori e personale universitario. Intervista alla D.ssa Elena Ippolito, responsabile del progetto iBicocca che da anni porta avanti la cultura dell’“innovazione, imprenditività e imprenditorialità”
Chi è Elena Ippolito
La D.ssa Elena Ippolito lavora presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca da 28 anni. Precedentemente ha lavorato 12 anni presso l’Università Statale di Milano. «Sono stata inizialmente ‘Vicesegretario amministrativo del Dipartimento’ di Matematica e poi ‘Segretario amministrativo dei Dipartimenti’ di Informatica e Matematica in Bicocca per 12 anni». Racconta Elena, “l’iMum”, come la chiamano i suoi ragazzi che seguono il percorso iBicocca, durante l’esperienza biennale al Tar Lombardia come ‘Capo Ufficio accettazione ricorsi e archivio generale’ ha deciso di iscriversi all’università e nel 2013 ha conseguito la Laurea in ‘Management pubblico’. Successivamente al suo rientro in Bicocca, coglie al volo un’occasione che le viene proposta, ovvero tradurre in Bicocca quanto dettato dal bando Startup – D.D. n. 436 del 13 marzo 2013 – pubblicato congiuntamente da Miur e il Mise (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; Ministero dello Sviluppo Economico, ndr.).
I due Ministeri esortavano nel bando le università, a dotarsi di misure per favorire l’imprenditività quindi la proattività nei ragazzi, in modo che gli stessi potessero lavorare insieme, pur provenendo da corsi di studi diversi, per la realizzazione di progetti imprenditoriali.
Elena stava frequentando in quel periodo il Master in ‘Open Innovation and Knowledge Transfer (MIT)’ presso il Politecnico di Milano, concluso a pieni voti nel 2015, quando, grazie alla collaborazione con Francesco Inguscio crea iBicocca.
La nascita di iBicocca
Nella progettazione di iBicocca, Elena è stata supportata da Francesco Inguscio, startupper con curriculum vitae degno di nota. L’ha conosciuto mentre era alla ricerca di spunti per realizzare un percorso di imprenditorialità per UniMiB.
«Il Direttore Generale mi ha detto: «Elena, devi capire qual è la misura giusta per tradurre il contenuto del bando startup nel nostro Ateneo». Quindi, ovviamente, per decidere che cosa realizzare, dovevamo comprendere quale fosse il bisogno. Si può dire che iBicocca è nata con lo stesso iter di una startup. Quindi, io e Francesco Inguscio, prima abbiamo sondato la conoscenza di certe tematiche tra gli studenti ospitando nel nostro Ateneo nel 2014 un evento che si chiamava ‘Mi Faccio Impresa’; L’iniziativa che era organizzata da un funzionario della Provincia di Milano, aveva collocazioni diverse nei diversi anni. Nell’edizione 2014 con sede nell’edificio ‘Agorà – U6’, avevamo invitato 15 startup che oltre a presentare il proprio modello di business agli studenti, hanno offerto loro la possibilità di proporsi per posizioni di stage. In quel contesto ha avuto luogo inoltre la prima edizione della “Bicocca Ideas”, competizione di idee made in Bicocca. Al termine dell’evento è stato somministrato un questionario ai partecipanti per comprendere il grado di conoscenze del mondo dell’imprenditoria ed è stata una sorpresa apprendere che erano passati da quell’evento circa 2000 studenti e che c’era una richiesta di approfondire le tematiche trattate. Questo ci ha dato la possibilità di analizzare i dati e di porre le basi del percorso iBicocca.»
Nel 2015 parte la prima edizione del percorso iBicocca con 280 studenti iscritti all’offerta formativa, che rilasciava già allora Open Badge creati ad hoc per essere convertiti in CFU (Crediti Formativi Universitari) per altre attività utili nel mondo del lavoro, ove il Piano di Studio dei partecipanti lo prevedesse. Al termine della prima edizione di iBicocca i feedback sono stati molto positivi e uno dei ragazzi prossimo alla laurea, che ha partecipato alle sessioni formative, una volta laureato ha addirittura fondato una startup.
iBicocca Titanium
Racconta Elena: «Il Titanium è un vero e proprio percorso di pre-accelerazione aperto a team che abbiano già un’idea abbastanza definita e che ambiscano a trasformarla in un’idea di business, fondando la propria startup. Noi ci avvaliamo della collaborazione di ‘weBeetle’, che è il nostro advisor per questo percorso. Il percorso è organizzato in sei “sprint”, in cui in sessioni plenarie vengono approfonditi tutti gli argomenti legati all’idea imprenditoriale; è previsto inoltre per ogni singolo team un percorso di approfondimento dedicato. Ogni singola squadra ha la possibilità di vedere crescere la propria idea, analizzando tutti quegli aspetti legati ad esempio al mercato, ai competitors piuttosto che alla ricerca dei finanziamenti, alla definizione di un executive summary, e ad un business model canvas un po’ più organizzato fino al business plan, che è il documento che in sostanza racchiude le condizioni per la fattibilità e la realizzazione di un’impresa. Il Business Plan mostra la capacità anche di avere dei guadagni e ovviamente vengono messi a punto i margini che la società avrà per permetterle di crescere velocemente e capire se effettivamente ha senso sviluppare l’idea imprenditoriale proposta. Inoltre, il business plan è sì una sorta di bilancio preventivo, ma anche la proiezione della crescita a 5-10 anni, molto apprezzata e richiesta dagli investitori.
Al termine del percorso Titanium ci sarà un evento finale alla presenza degli investitori in cui verranno premiate le tre migliori idee. Se uno di questi tre team costituirà la start up entro la fine dell’anno, gli investitori erogheranno un primo finanziamento. Questo evento offrirà una vetrina vera e propria, tutti i partecipanti avranno la possibilità di conoscere una serie di soggetti che poi possono facilitare la crescita dei propri progetti.»
Il primo ciclo di iBicocca Titanium ha visto la candidatura di ben 44 team tra ricercatori, dottorandi, personale amministrativo e studenti. Dal bando si evince la volontà di creare collaborazione intra ed extra Ateneo: il gruppo deve essere composto da almeno un componente afferente all’’Università degli Studi di Milano – Bicocca, mentre gli altri membri possono essere persone esterne alla comunità Bicocca.
Hanno superato la prima selezione 21 squadre, scelte in base al grado di fattibilità del progetto e alle competenze presenti nel team. Non ci sarà particolare competitività tra i team in quanto ognuno di loro si occupa di un pezzo di mercato che non collide con gli altri.
Elena non perde occasione per regalare qualche consiglio basato sulla sua esperienza: «faranno un pitch tutti i team che arriveranno al termine del percorso con un team completo, inteso come competenze complementari e diverse tra loro. Noi abbiamo sempre detto che uno dei punti di forza di una startup è proprio il team. Gli investitori, di fatto, investono più sulle persone, che sull’idea; nel tempo abbiamo visto che solo le aziende con un team molto forte, affiatato, ma eterogeneo, hanno i presupposti per avere successo. I componenti del team stesso devono avere necessariamente competenze diverse: lo sviluppatore, ad esempio, che mette a punto il dispositivo e lo brevetta, non può essere lo stesso che si occupa del Business Plan perché hanno una formazione diversa, i due devono lavorare comunque insieme ma con ruoli e responsabilità compatibili con il proprio percorso di studi. Questa ricchezza di conoscenza è uno dei punti di forza per crescere velocemente.»
Cosa si aspetta il team iBicocca da questo nuovo progetto?
«È un grandissimo successo aver visto 44 team iscritti. Abbiamo guardato le presentazioni delle idee, siamo molto contenti perché alcune sono veramente fatte molto bene. In realtà, molti degli esclusi (per lo più per una questione di possibilità di seguirli correttamente piuttosto che per il grado di definizione dell’idea) verranno comunque recuperati perché noi ci teniamo a supportare il più possibile tutti coloro che ci credono e che vogliono crescere. Personalmente mi aspetto al termine del Titanium almeno quattro startup pronte per i primi mesi del 2025.»
Noi del team di iBicocca siamo un gruppo molto compatto. Ognuno di noi, come in una startup, ha competenze diverse, pur essendo abbastanza intercambiabili, ma abbiamo l’obiettivo comune di lavorare con efficacia, competenza e disponibilità, per fare in modo che i ragazzi abbiano un supporto costante e di qualità. Salutando “la iMum ” le faccio un grande augurio per questa e per le prossime edizioni. Sono certo che ogni gruppo sfrutterà al massimo questa occasione!