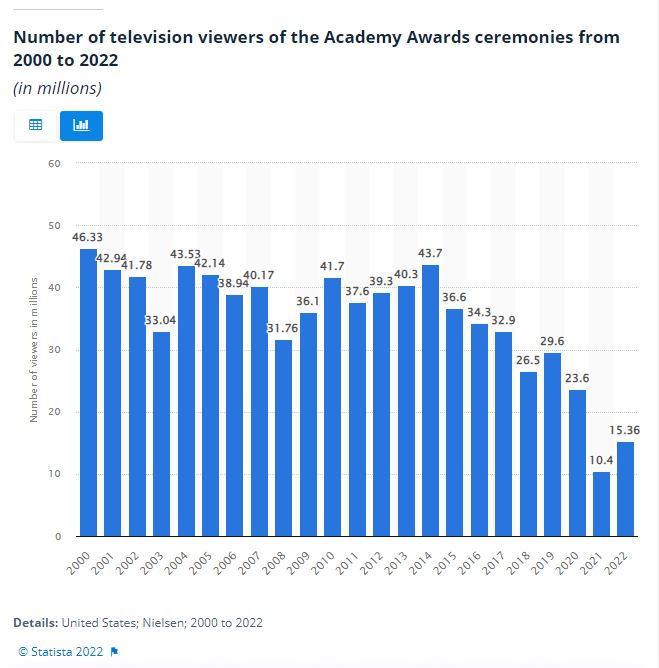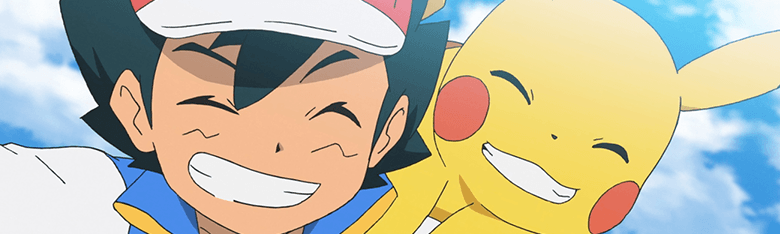Copywriter, direttore creativo, formatore e imprenditore, Davide Bertozzi è autore di “Immagini VS Parole” e con le parole e la creatività, ci lavora da sempre. Al Web Marketing Festival è stato presente in qualità di relatore, il suo talk, intitolato: “Forzare la creatività” si è tenuto al mattino, e ne riporteremo il riassunto, al pomeriggio invece l’abbiamo intervistato per scoprire qualcosa in più del suo percorso e non solo.
Davide ha iniziato il discorso parlando di cosa non è la creatività, ovvero la proverbiale lampadina che si accende se si sta lì per un po’ ad aspettare. In realtà è ben altro: non si accende in nessun modo se non si fa niente, e come lui stesso dice: “La creatività è piuttosto un percorso e tra noi e la destinazione ci può essere di tutto, per trovare l’idea creativa bisogna affrontare un po’ di cose e più o meno ci si arriva”.
La creatività dunque è un’anomalia, che spesso le persone e le aziende non colgono, come in un esempio che ci ha portato: dalla home page del sito di un celebre brand italiano, ci sono 23 pulsanti con sopra scritto “scopri di più”, e questa scelta di sicuro non è creativa, bensì, come ha scherzosamente detto Davide, è “la morte della creatività”.
Ma cosa serve dunque per scrivere un testo “anomalo”? Secondo Davide: chiarezza, personalità e rispetto del tono di voce; rispondendo allo stesso tempo a tre domande fondamentali: di cosa scrivo, per chi scrivo e perché ne scrivo.
L’intervento si è concluso con numerosi consigli pratici, il resto è stato raccontato nell’intervista.
Davide, il tuo speech s’intitola “Forzare la creatività” e guardando al tuo lavoro, la creatività sembra essere al centro, ma cos’è per te davvero la creatività?
Per me la creatività è un’anomalia, come dicevo stamattina, ma voglio comunque partire dalla definizione classica di creatività, pronunciata dal matematico Henri Poincarè, che noi pubblicitari condividiamo essere la definizione migliore: “la creatività è la capacità di unire elementi già esistenti in modo nuovo e utile”. Ecco, è il nuovo e utile che secondo me rende una cosa creativa: non è nulla che si inventa, al contrario è un’intenzione di far qualcosa di fondamentalmente diverso. La creatività è ovunque, l’importante è impegnarsi, perché se stiamo seduti ad aspettare che si accenda la lampadina e ci venga l’idea, sicuro come l’oro che non ci viene, io dico sempre che la creatività è un percorso progettuale da percorrere: sporcarsi un po’ le mani, fare tentativi e progetti per arrivare poi al risultato finale, che si raggiunge solo dopo molta esperienza e pratica. A me non piace parlare di scrittura creativa perché autodefinirsi creativi è come autodefinirsi belli o intelligenti, dovrebbero dirtelo gli altri. Preferisco invece parlare di scrittura che funziona, è creativa quando funziona perché si possono pure scrivere cose belle, originali e divertenti, ma se queste non vengono comprese correttamente dal pubblico, non vendi, i clienti non sono contenti e quindi la creatività, a quel punto, serve a poco. La creatività poi esiste a più livelli, puoi scrivere creativamente anche un biglietto di auguri, la scrittura creativa non è solo quella che fa ridere, ma è molto di più, e ogni tipo di progetto richiede uno sforzo creativo, per questo non mi sento di dire che la creatività è una: si manifesta in molte forme.
Rimanendo sul tuo lavoro, sei un copywriter e direttore creativo, riusciresti a spiegare il ruolo di queste figure in poche parole per chi non ne sa nulla?
Lo spiego come se lo spiegassi ai miei genitori (mia mamma non ha ancora capito cosa faccio davvero), detto in modo brutale; il copywriter è la persona che scrive i testi pubblicitari ovvero i testi che servono a convincere qualcuno a comprare qualcosa, oppure, se l’obiettivo finale non è la conversione alla vendita diretta, può essere mantenere la reputazione del brand per impreziosire la percezione di un marchio, di un prodotto o anche di una persona e si deve sempre scrivere per valorizzare qualcosa. Questo è quello che un copywriter fa, a molti piace mettere le etichette distinguendo web copywriter, SEO copywriter, digital copywriter e via dicendo, ma secondo me sono figure che, usando canali diversi, lavorano sempre con le parole, specializzandosi, ma senza fare nulla di troppo diverso in fondo: per me il copywriter rimane uno, ovvero colui che convince le persone a comprare.
Il ruolo di direttore creativo, invece, arriva dopo un po’ di tempo. Io ho iniziato come copywriter, ho sempre scritto tantissimo e dopo la triennale ho trovato subito lavoro in uno studio grafico e non ho più ripreso a studiare, purtroppo. Dopo due anni ho aperto la partita IVA, perché sono quel tipo di persona che dopo un po’ si annoia e vuole cambiare posto. Ho pensato che se mi fossi staccato da un’unica realtà e avessi iniziato a lavorare con tutti avrei potuto vedere diverse aziende e collaborarci, sulla carta l’idea funzionava, poi c’è voluto molto alla vera attuazione. Collaborando con diverse imprese, mi sono reso conto che in moltissime di queste non vi era la figura del direttore creativo, cosa che in altre agenzie, in luoghi come Londra, è fondamentale avere. In Italia, invece, spesso non ci sono, o ci sono persone che si improvvisano tali, e quindi mi sono messo ad osservarle, notando gli errori e lasciando fare, capendo come avrei potuto farlo meglio. Solo dopo qualche anno, lo confesso, ho iniziato a improvvisarmi direttore creativo: pian piano ho imparato. É un ruolo importante perché, se non c’è qualcuno che guida la barca, la campagna pubblicitaria non viene granché. Inoltre c’è voluto un po’ per imporre questo mio modo di lavorare alle aziende con cui collaboro; spesso finisci per non star troppo simpatico se vuoi che le cose vengano fatte in un certo modo, come ritieni meglio, ma è necessario definire bene gli obiettivi del progetto e il modo di procedere per rendere la campagna efficace e avere il cliente soddisfatto. La differenza tra il ruolo del copywriter e il direttore creativo, è che il primo scrive i testi pubblicitari e a volte inventa l’idea del progetto, mentre il secondo, che può essere un copy o un art director, è quello che deve impostare la squadra, il lavoro e tenere le redini di tutto il progetto. Non sempre è colui a cui viene in mente l’idea, però è colui che indica la strada e che tutti poi devono seguire. Ho scelto questo ruolo perché è di responsabilità e non ho paura di assumermela mettendoci la faccia e andando dal cliente, l’importante è che tu sappia spiegare ogni dettaglio all’azienda con la quale stai lavorando. Mi piace particolarmente quando i progetti, se fatti bene, iniziano e finiscono che tutti sanno quello che fanno, e penso che tutti debbano essere soddisfatti, deve piacere ciò che si fa e se non piace, cerchiamo delle soluzioni assieme perché tutti i componenti del team devono metterci del loro, ponendosi la famosa domanda: “cosa ne penso”, come dicevamo questa mattina, altrimenti il progetto ne risente di qualità.
Sei anche un formatore e ti sei occupato di diversi progetti tra cui fondare una tua realtà, qual è l’insegnamento più grande che ti porti a casa ad oggi da tutte queste attività multidisciplinari?
Sento di star imparando un sacco, in primis come formatore: da quando insegno, mi capita almeno tre o quattro volte l’anno di incontrare qualcuno che ne sa più di me, anche se è giovanissimo, risulta molto più ferrato su un argomento e magari ha un talento talmente grande che riesce a scrivere cose che tu arrivi a creare con fatica. Da un lato è preoccupante, ma dall’altro ti incentiva a non metterti mai a sedere, perché secondo me, un problema che ha spesso chi insegna, è di adagiarsi senza aver voglia di mettersi in discussione quando si incontrano persone più in gamba. A me invece queste persone danno la carica giusta per rimanere sul pezzo e anzi, mi piace circondarmi di giovani talentuosi per restare in contatto con loro e continuare ad apprendere e migliorare senza mai pensare di essere arrivato.
Parlando di multidisciplinarietà inoltre, per me è fondamentale per comprendere a fondo le cose: persino nei miei corsi, investo delle ore parlando di tutt’altro che non sia scrittura, ad esempio partendo dalla storia dell’arte e facendo un percorso, si arriva alla fine con una maggiore consapevolezza, perché si è affrontato l’argomento a 360 gradi.
Secondo te, la creatività sarà importante nei cosiddetti lavori del futuro? e se sì come?
Sono dell’idea che gli strumenti con cui lavoriamo in comunicazione, riducendo all’osso, sono due: immagini e parole, ed è così da quando l’uomo ha iniziato a scrivere e ad oggi, anche se usiamo tecnologie super avanzate, alla fine utilizziamo sempre queste due per comunicare. Secondo me la creatività serve e servirà sempre, perché è la chiave che ti aiuta a fare meglio le cose al di là del mezzo, lo spunto creativo ti serve per lavorare meglio e le idee creative servono a migliorare quello che si fa.
Per quanto riguarda i lavori del futuro, noto che tutto il processo di automazione comincia a diventare complicato per chi si occupa di scrittura: innanzitutto bisogna scrivere dei testi che verranno letti e pronunciati da delle macchine e queste nuove modalità vanno testate parecchio. Pensa banalmente alla SEO: ciò che vogliamo cercare non lo digitiamo più su Google e fine, a momenti ci parliamo proprio con questi motori di ricerca. Diventa quindi necessario capire quali sono le parole che le persone utilizzano adesso e quali utilizzeranno tra dieci anni, a mio avviso bisogna conoscere e lavorare con i giovani per capirlo. In conclusione, riguardo al futuro, secondo me dovremo saper scrivere parole che verranno pronunciate da una macchina e dovremo essere pronti a dare le risposte a domande fatte con i vocali: essere in grado di incrociare questi tipi di comunicazione non è semplice, ma sarà la sfida per i copywriter dei prossimi 10 anni.
Parlando di comunicazione, secondo te perché ad oggi è così importante che un brand, un’azienda, comunichi bene?
É importante perché il marketing di oggi, quello 4.0 che aveva teorizzato Kotler nel suo ultimo libro, non è più il marketing anni ‘80 in cui le persone continuavano a sentirsi ripetere di dover comprare: le persone non vogliono ricevere degli ordini e con i social la distanza tra aziende e persone si è ridotta, entrambi hanno lo stesso valore, dunque persone e aziende devono parlare con lo stesso tono di voce. Le aziende dovrebbero aprirsi alla comunicazione più autentica, e per autentica intendo meno autoreferenziale, comunicando il perché queste persone possono fare cose grandi con i prodotti di quella realtà, ti devo essere utile e non darti degli ordini. Per fare questo serve un tono di voce più umano, più amichevole, più vicino, non deve essere per forza spiritoso, basta una comunicazione più vera, come dicevamo stamattina, cioè l’azienda deve capire esattamente cosa le persone vogliono ascoltare: è più importante ciò che gli altri capiscono rispetto a cosa dici.
Hai parlato di comunicazione più umana spiegando cosa significa e come renderla effettivamente tale, ma secondo te adesso in che direzione si sta andando? quale sarà il trend comunicativo da qui ai prossimi anni?
Mi trovo stranamente d’accordo con una frase di Mark Zuckerberg che dice: “secondo me il futuro dei social è privato”, perché se io scrivo ad un brand gigante riguardo al problema che ho con un loro prodotto e loro mi rispondono con una persona e non un robot, per me è una cosa bellissima e quindi le aziende dovrebbero aprirsi ad instaurare un rapporto vero con le singole persone che vogliono chiedere qualcosa, che hanno un problema. Questo significa aprirsi ad una comunicazione privata e non solo inviare numerose newsletter e DEM, basta con la comunicazione di massa, bisognerebbe mandare messaggi privati mirati alle singole persone.
Per quanto riguarda la direzione che sta prendendo la comunicazione, ultimamente c’è stato il fermento del real time marketing, in Italia inizialmente è stato fatto da pochissimi che hanno avuto successo e tutti quelli che sono venuti dopo di loro hanno fallito, semplicemente perché quando copi qualcuno al massimo arrivi secondo. Quando copi, in aggiunta, non riesci a capire fino in fondo il coraggio che loro hanno avuto a fare certe cose molto inusuali: il caso di Taffo, ad esempio, che ha portato la comunicazione social di un’agenzia funebre facendo black humor. Spesso le aziende non hanno il coraggio di intraprendere comunicazioni inusuali perché è lo stesso direttore marketing che blocca tutto pensando che non vada bene, che non sia classico, e io tipicamente rispondo che è quello il motivo per cui funziona.
Hai scritto “Immagini VS Parole”, ci daresti un piccolo assaggio di questo libro? a livello comunicativo, come impattano diversamente queste due forme di comunicazione?
Ti cito la frase con cui inizia il libro: “le immagini sono parole e le parole sono immagini. E questo libro potrebbe anche finire qui”, questo è ciò in cui credo: le immagini e le parole sono la stessa cosa anche se il titolo è ovviamente una provocazione. Parto dal luogo comune secondo il quale un’immagine vale più di mille parole, secondo me non è vero e nel libro non faccio altro che motivare questa mia convinzione. Ti spiego subito perché le immagini sono parole e le parole sono immagini allo stesso tempo, arrivando al succo e saltando tutto il percorso che è il libro: il solo allineare un testo o scegliere un font significa che si sta considerando il testo come immagine; i font servono perché devono dare un aspetto estetico alle parole e già qui, immagini e parole iniziano ad essere la stessa cosa. Dopodiché proseguo e negli ultimi capitoli, parlando del rapporto tra visual e copy in una campagna pubblicitaria, giungo al capitolo dedicato al words hacking dove tipicamente il lettore rimane di stucco quando scrivo qualcosa del tipo: “katana” con la “a” tagliata e a quel punto chiedo: “quella adesso è un’immagine o una parola?”. Non è importante la risposta, è importante che tu abbia capito il concetto e che lo sappia applicare; chiamala immagine, chiamala parola, chiamala come preferisci ciò che conta è che le persone capiscano quello che stai cercando di comunicare.